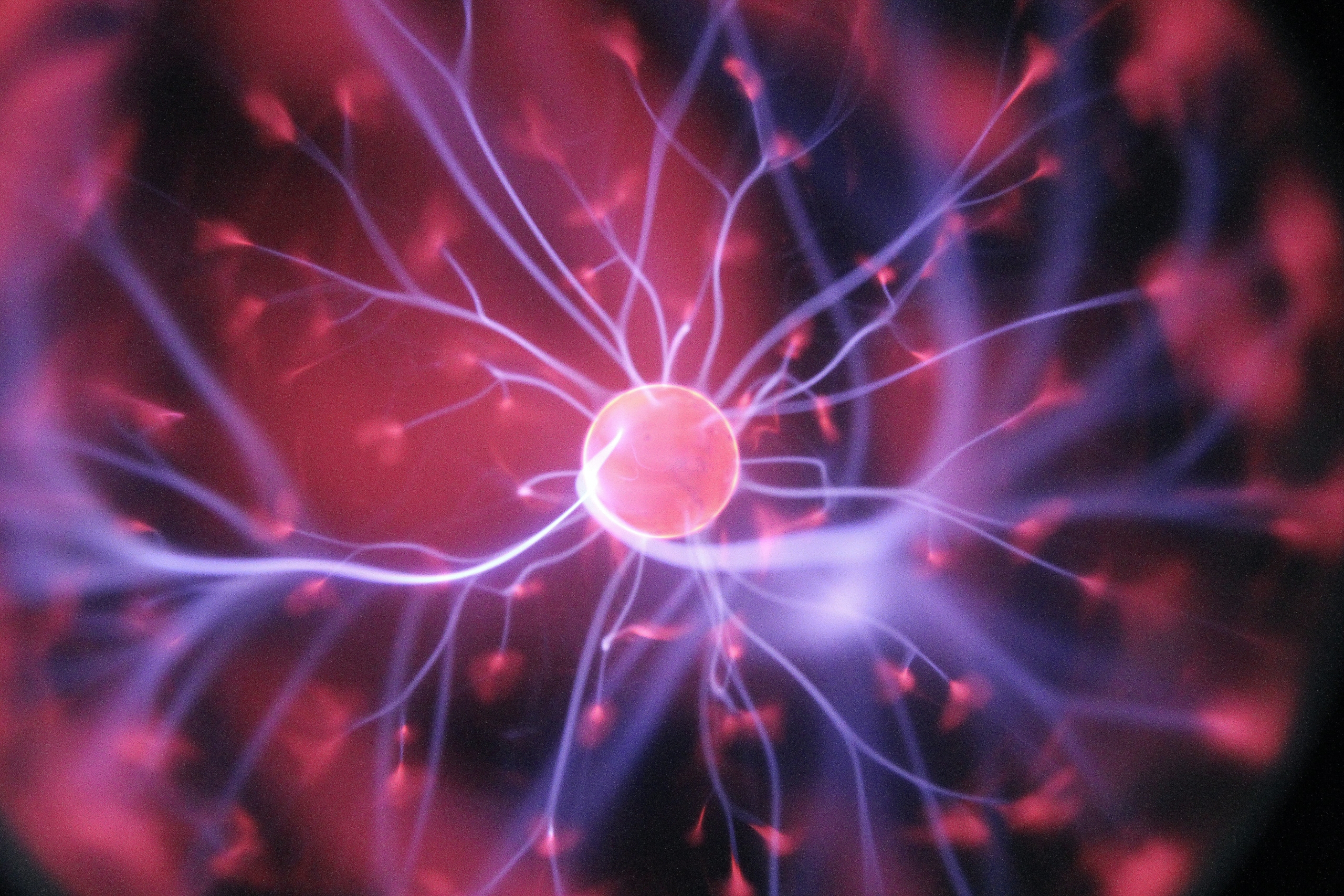Alexandre Koyré è stato un filosofo della scienza che si è occupato più volte di storia della scienza. Durante il suo percorso filosofico (nato nel 1892 a Taganrog, nella Russia meridionale, ha poi lavorato a Parigi e Gottinga, rispettivamente con Bergson e Husserl) Koyré ha in particolare analizzato i rapporti fra la tecnologia e la scienza.
In due brevi saggi riuniti per Einaudi nel volumetto Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Koyré si occupa di ricercare il perché nel mondo greco e antico in generale, malgrado alcune preziose illuminazioni, è emersa una certa stagnazione della tecnica. Scrive: «il grande problema che preoccupa tanto la storia della civiltà quanto quella delle tecniche non è spiegare perché vi furono macchine in Egitto, in Grecia e a Roma, ma, al contrario, spiegare perché ve ne furono così poche, spiegare non il progresso, ma la stagnazione» (p. 63).
La spiegazione psicosociologica
Koyré riporta approfonditamente una possibile spiegazione di questa non-evoluzione tecnologica del mondo antico, che possiamo definire «psicosociologica». Questa si fonda sull’analisi della struttura socio-politica – e quindi necessariamente psicosociale – del mondo antico che, riassumendo: disprezzava il lavoro manuale, considerato in opposizione alla vita intellettuale e contemplativa; promuoveva l’esistenza della schiavitù; concepiva la theoría come ontologicamente superiore alla praxís; riteneva che la natura fosse superiore all’arte e che quest’ultima potesse solo imitarla, non certo superarla o concepirla diversamente.
È per questo, spiega Koyré, che «il mondo antico non ha sviluppato un macchinismo e in generale non ha fatto progredire la tecnica» (p. 69), perché ha valutato ciò come di alcuna importanza. Il mondo moderno, al contrario, ha individuato come importanti le capacità del macchinismo e della tecnica, e perciò ha investito sul loro sviluppo.
Tuttavia il contesto non può interamente dar conto della nascita di un fenomeno: questo vale per un fatto storico, per un evento politico, ma anche – dice Koyré – per un aspetto storico-filosofico come il progresso della tecnica. In altre parole, la spiegazione psicosociologica richiede una qualche forma di completamento. Anzi, e di più: schiacciarsi sull’idea che il contesto psicosociale possa esaurire le spiegazioni del perché nel mondo antico lo sviluppo della tecnica si sia bloccato, vuol dire non riconoscere le forze che contribuiscono a creare tali contesti.
Come scrive Koyré è necessario andare oltre una spiegazione psicosociale, perché questa non sarà mai in grado di dare una risposta compiuta al fatto che, ad esempio, «i marinai greci, così intelligenti, così intraprendenti, così arditi e fieri di sé (come d’altronde lo erano i marinai fenici o cartaginesi), non abbiano mai avuto l’idea di sostituire al remo-timone della loro nave un vero timone […]» (pp. 75-76).
Tecnica e scienza
Del resto, la spiegazione psicosociologica «si fonda interamente sulla premessa implicita della dipendenza della tecnica riguardo alla scienza» (p. 84). Ovvero la scienza – e con essa tutto il portato storico-culturale di sfondo –, secondo la spiegazione psicosociologica, influenza direttamente la tecnica che segue i dettami di questa. Lo stesso Platone definisce la techné abitudinaria per essenza, un processo di ripetizione di formule stagnanti nel tempo e niente affatto innovative. Su questo ultimo punto, dice Koyré in nota, «lo spirito abitudinario del contadino, […] è una conferma clamorosa» (p. 84).
Eppure, se si guarda con più attenzione al processo di influenza fra tecnica e scienza, vediamo che nella storia umana la techné precede sempre l’epistème. La tecnica più che ricevere indicazioni metodologiche e concettuali dalla scienza, ha conquistato alcuni suoi traguardi attraverso una dinamica prove-ed-errori. È dunque più corretto dire che, nella storia dell’uomo, esiste un pensiero tecnico, ovvero un «pensiero pratico essenzialmente differente dal pensiero teorico della scienza» (p. 85), quasi pre-scientifico in quanto empirico, che ha permesso di sviluppare mestieri, regole d’arte e procedure reiterate nel tempo. L’incapacità di questo pensiero di innalzarsi e quindi di generalizzarsi, è stato il suo limite. Ecco dunque dove risiede, in ultimo, la stagnazione della tecnica nel mondo greco-antico: nella mancata abilità del pensiero tecnico di farsi generale, di stabilire delle norme concettuali.
Questa analisi conduce Koyré a porsi due ulteriori domande: 1) perché appunto il pensiero tecnico non si è innalzato a un livello superiore?; e 2) perché i greci non hanno «sviluppato una tecnologia di cui aveva[no] pur formulato l’idea»? (pp. 85-86).
A queste due domande la spiegazione psicosociologica non riesce a dare una risposta: è pertanto necessario andare oltre e capire quale ruolo abbiano giocato le idee.
L’esattezza
Il concetto che sta alle spalle delle due domande che si pone Koyré è parte integrante della sua proposta di lettura della storia della scienza. Per Koyré, infatti, il pensiero greco non ha davvero elaborato una vera fisica. Ma quando parla di fisica Koyré intende una cosa ben precisa: l’inserimento, tutto moderno, della matematica all’interno della natura. In altre parole aver reso il mondo naturale un ente misurabile, geometrico. Per il mondo greco la natura è il luogo del pressappoco (p. 91); i cieli e i movimenti delle sfere celesti sono al contrario il mondo della perfezione.
La dualità radicale fra questi due ambiti e la loro inconciliabilità ha rappresentato, per il mondo greco, uno scalino invalicabile. La tecnica greca è rimasta al livello della techné poiché la precisione dei cieli non è “scesa” sulla terra. Il mondo moderno, al contrario, matematizzando la natura ha intrecciato una teoria fisica a una teoria tecnologica, ponendo così le basi di uno sviluppo del macchinismo. Il mondo, per la mentalità moderna, non solo si analizza e si osserva, ma si cambia, perché si è capaci di parlare la sua stessa grammatica interiore. Questo, osserva Koyré, non toglie che parte della spiegazione psicosociologica continui a trovare ragione anche nel mondo moderno; ma anche qua essa non esaurisce la domanda e, soprattutto, non coglie l’essenza profonda delle motivazioni.
La differenza fra scienza antica e moderna sta quindi nell’assenza di un’idea di tecnica nella prima: «non si guarda finché non si sa che c’è qualcosa da vedere, e soprattutto finché si sa che non c’è nulla da vedere» (p. 100). È dallo spostamento dell’episteme nella praxis che nasce una prospettiva di precisione anche nell’ambito naturale. In questo contesto è lo strumento, la macchina, il mezzo attraverso cui «la precisione si incarna nel mondo del pressappoco» (p. 111), perché essa può mutare l’ordine delle cose e renderle somiglianti all’idea che l’uomo ha costituito. La costruzione degli strumenti è il pensiero tecnologico.
Aspetti critici della lettura di Koyré
Koyré affronta un motivo centrale della storia del pensiero con grande lucidità e nel tentativo, dichiarato, di inglobare tutte le variabili che hanno contribuito a renderlo così importante. Ciononostante la lettura fa emergere almeno un paio di questioni sulle quali interrogarsi ancora. In primo luogo, Koyré sembra parlare da una prospettiva deliberatamente moderna; quando parla di fisica egli intende infatti la fisica dei moderni, quella possibilità di descrivere il mondo more geometrico. Nella sua analisi, in altre parole, non si mette mai in dubbio la possibilità che la matematizzazione della natura sia una forzatura dell’uomo moderno, una sua volontà di impossessarsi della possibilità di cambiare il corso degli eventi. Il moderno appare una evoluzione dell’antico.
In secondo luogo, e in modo complementare a questa rilevazione, è necessario chiedersi – cosa a cui Koyré non accenna – se il mondo della natura sia davvero (e ancora) incontrovertibilmente matematico. Le leggi della natura elaborate dalla filosofia scientifica moderna hanno subito un duro colpo nel corso del Novecento, da parte dei principi di indeterminazione di Heisenberg e dalla relatività einsteinana, per fare due esempi. Come ha scritto magistralmente Hans Reichenbach: «quella che prima era considerata una legge di natura assoluta ha finito per rivelarsi una mera legge statistica, non più affatto certa, bensì solo altamente probabile» (p. 160). Ciò non significa bollare la scienza di irrazionalità, ma nemmeno di renderla all’altezza di porsi come Teoria del Tutto (le due polarità estreme di ogni discorso che ragioni sulla validità degli approcci scientifici).
In conclusione, non si intende accusare Koyré di alcunché ma semmai di utilizzare la sua lettura per provare a muoversi nell’attuale confusione sul ruolo della scienza e della tecnica. Nella civiltà della tecnica gli uomini richiedono alla scienza (perfino alla medicina) risposte certe, sicure, incontrovertibili. La scienza e tutto l’apparato tecnologico sembrano sempre di più assumere un ruolo salvifico per le vite delle persone. Ed in parte lo sono, per fortuna. A loro però è richiesto di inserirsi all’interno dei meccanismi della natura e di modificarli senza margine d’errore. Una richiesta non solo sbagliata ma anche rigonfia di fede e irragionevole devozione.
In verità, l’universo della precisione, sceso nel mondo del pressappoco, si è trasformato in una terra dove tutto può essere misurato e calcolato: fino ad un certo punto.
Bibliografia:
A. Koyré, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Einaudi, 2000[3]
H. Reichenbach, La nascita della filosofia scientifica, Il Mulino, 1961
Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash