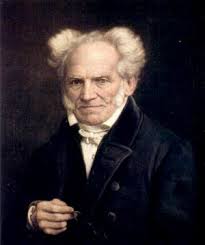Tra le molte interpretazioni di Spinoza la più accreditata è quella del pensatore razionalista, cristallo puro della filosofia, grazie al quale è possibile ricostruire l’intera realtà del mondo tramite una rigida e perfetta connessione causale, dalla macchia che appare sul pavimento fino a Dio. Lo Spinoza di Della Rocca, testo pubblicato per le edizioni della Routledge nel 2008, si inserisce in questo filone. Secondo il docente americano il principio di ragion sufficiente, in base al quale niente può darsi senza una causa, è il fondamento dell’intera speculazione del filosofo ebreo-olandese. Variamente enunciato nel corso della storia del pensiero filosofico, il principio di ragion sufficiente viene attribuito a Leibniz che ne ha elaborato la forma definitiva e maggiormente conosciuta. Spinoza, oltre a darne una interpretazione più radicale, ne fa il punto di partenza per costruire tutto il suo pensiero. Suddiviso in otto capitoli, il libro di Della Rocca mostra come il principio in oggetto sia lo strumento per comprendere qualsiasi area tematica spinoziana: epistemologia, metafisica, etica, politica, religione. A motivo di questa coerenza del sistema, Spinoza è davvero il supereroe della ragione.
L’impossibilità dell’irrazionale
Della Rocca, docente alla Yale University, è esplicito fin dalle prime pagine: «Spinoza’s philosophy is characterized by perhaps the boldest and most thoroughgoing commitment ever to appear in the history of philosophy to the intelligibility of eveything. For Spinoza, no why-question is off limits, each why-question – in principle – admits of a satisfactory answer» ((M. Della Rocca, Spinoza, London and New York, Routledge, p. 1.)). Questo impegno emerge in due luoghi specifici. Il primo nella Proposizione 11 della prima parte dell’Etica (inizio dell’aliter 1) secondo cui «Di ciascuna cosa si deve assegnare la causa, o ragione, tanto del perché esiste, quanto del perché non esiste. Ad esempio, se un triangolo esiste ci dev’essere una ragione, o causa, per cui esso esiste; e se non esiste deve parimente esserci una ragione, o causa, che impedisce che quel triangolo esista o che elimina la sua esistenza. Questa ragione o causa deve trovarsi o nella natura della cosa considerata o fuori di essa». Spinoza utilizza una endiadi: si deve dare una causa o ragione dell’esistenza di ogni cosa precisando, allo stesso tempo, che questa causa determinata si deve dare anche della non esistenza della cosa. Come infatti non si danno esistenze contingenti, non si possono nemmeno dare non esistenze contingenti. Coloro che conoscono il pensiero di Spinoza, sanno che questa impossibilità è enunciata anche nel Breve Trattato (KV I, 3-6) dove il principio di ragion sufficiente (PRS) viene indicato in altri modi ovvero come Dio causa di tutto, opera necessaria di Dio, provvidenza e predestinazione divina. In tutti i casi non c’è nulla che sfugga alla domanda “perché esiste?”: il principio di ragion sufficiente vuole che se una ragione non è interna alla cosa, se ne dia comunque una esterna ((Cfr. M. Guéroult, Spinoza I: Dieu (Éthique, I) , Aubier-Montaigne, Paris 1968, p. 12)).
Il secondo luogo in cui emerge il principio in esame è l’assioma 2 della prima parte dell’Etica secondo cui «Ciò che non può essere concepito per altro deve essere concepito per sé». Con tale assioma Spinoza inserisce la nozione di intelligibilità nel cuore del suo sistema, nozione che lo conduce al naturalismo e all’impossibilità di parlare di qualcosa che sia contro o sopra natura (che per Spinoza non divergono nel loro significato ultimo). Nessuna menzione viene riservata al fatto che questo assioma non sia stato utilizzato nell’Etica sollevando così dubbi sulla sua funzione: per usare una metafora, è come se Spinoza avesse posto delle fondamenta senza costruirci sopra. Omero Proietti, dopo una lunga ed erudita analisi filologica, sostenne trent’anni fa che esso (a differenza di quanto pretendeva la critica) era lungi dall’essere inutile e che non costituisse una mera ripetizione dell’assioma che lo precede ((O. Proietti, Sul problema di un assioma inutile in Spinoza, Vita e Pensiero, vol.75, no.2, aprile-giugno 1983, pp.223-242)). L’articolo di Proietti suggeriva l’idea che l’assioma riguardasse la natura dell’attributo in quanto fosse da riferire alla proposizione 10 della prima parte. In questo modo, l’attributo doveva essere considerato come avente natura concettuale rendendo inutile la contrapposizione post-hegeliana tra i fautori dell’interpretazione realista e quelli dell’interpretazione nominalista. Questione storiografica enorme e scabrosa. Per ora ci basti dire che prendere sul serio l’assioma 2 significa fare i conti anche con l’incompletezza dell’Etica la quale, se è cristallo puro riguardo alla logica concettuale, non lo è in relazione al testo pervenutoci il quale mancherebbe di una parte essenziale.
In tutti i casi non c’è nulla che sfugga alla domanda “perché esiste?”: il principio di ragion sufficiente vuole che se una ragione non è interna alla cosa, se ne dia comunque una esterna.
La vittoria contro lo scetticismo
Il PRS viene utilizzato da Spinoza in due modi. Da una parte per la spiegazione della causa, la quale consiste nel rendere intelligibile un suo effetto. Dall’altra nella spiegazione di questa intelligibilità: «For Spinoza, to be is to be intelligible. This is the most fundamental statement of his rationalism, and it is the most fundamental instance of the twofold use of the Principle of sufficient reason» ((M. Della Rocca, op. cit., p. 9)). Si tratta della spada che sconfigge lo scetticismo: la ragione, in quanto contenga l’idea vera data, origine delle idee chiare e distinte, è in grado di affermare o negare qualcosa. Come scrive Popkins «un’idea per Spinoza è un modo di pensare la cui verità o falsità si mostra. Non occorre nessun regresso all’infinito di metodi, perché avere un’idea vera è lo stesso che conoscere perfettamente una cosa (…). Qui non può sussistere nessun problema scettico: o si conosce, e si sa di conoscere, o si è nell’ignoranza» ((R. Popkin, Storia dello scetticismo (tit. orig. The history of skepticism, 1979) Milano, Mondadori, 2000, 279.)). La verità è indice suo e del falso. Lo scettico radicale, spiega Della Rocca, separa il carattere rappresentativo delle idee (cioè la chiarezza e distinzione) dal loro carattere epistemico, cioè quanta conoscenza esse contengano effettivamente. In questo modo i due momenti possono non coincidere e da ciò la conseguenza scettica. Spinoza rifiuta questa distinzione in quanto inesplicabile, allo stesso modo in cui rifiuta la biforcazione tra mente e corpo, intelletto e volontà, coscienza e rappresentazione.
PRS forte vs PRS debole
Le tesi di Della Rocca hanno generato un certo dibattito. Nel numero di giugno 2015 del Journal of the History of Philosophy (sezione Notes and Discussion), negando la premessa a loro fondamento consistente in una presunta purezza teorica del sistema, Daniel Garber, docente dell’Università di Princeton, ha sostenuto che lo Spinoza storico è al contrario impegnato a risolvere problemi etico-religiosi e politici del suo tempo. In altre parole, Spinoza avrebbe scritto non tanto per interessi speculativi quanto piuttosto con finalità di carattere educativo, teologico o politico tali da subordinare ad esse qualsiasi interpretazione metafisica. Di conseguenza viene contestata l’esistenza di una chiave unica per comprendere il suo pensiero. In particolare, riguardo alla proposizione 11 della prima parte dell’ Etica sopra indicata, il docente di Princeton afferma che l’effettivo campo di applicazione del principio di ragion sufficiente è più ristretto rispetto a quello che ne fa il collega di Yale. Esso, una volta posta la distinzione tra cose e fatti, si applicherebbe ai primi ma non ai secondi con la conseguenza di avere un principio di ragion sufficiente più debole rispetto a quello forte invocato da Della Rocca e tale da essere più vicino al modo in cui l’intese Leibniz (che vedremo meglio la prossima settimana). Punto cruciale dell’argomentazione di Garber consiste nell’affermare che è la stessa natura di Dio ad essere il principale fatto bruto: perché infatti, sostiene lo studioso, essa è tale per cui (ad esempio) Harry esiste ed Eunice no? Anche se si volesse sostenere che tutto è intelligibile, ciò non esclude almeno un fatto bruto consistente nella stessa natura di Dio. L’argomentazione ricorda così quella di Bertrand Russel che proprio sull’esistenza dei fatti finiva non solo per negare il principio di ragion sufficiente ma rifiutava addirittura di considerare come filosofia quella di Spinoza.
Nella risposta Della Rocca ha contestato al suo interlocutore la possibilità di distinguere tra fatti e cose nella dottrina di Spinoza (punto sul quale concordiamo). Riguardo alla natura di Dio come fatto bruto, Della Rocca ha ribattuto che l’esistenza di Harry non solo spiega Harry ma anche la circostanza che Harry discende dalla natura di Dio: se esistesse Eunice, esisterebbe un’altra natura di Dio e ciò implicherebbe direttamente contraddizione perché si avrebbero due sostanze nella natura stessa di Dio. Cerchiamo di spiegarlo in altri termini. La proposizione 33 della prima parte dell’Etica si preoccupa di correggere il pregiudizio secondo il quale la potenza di Dio si manifesta al di fuori di leggi e regole. Per Spinoza, la potenza di Dio non può manifestarsi capricciosamente o attraverso mutazioni: se infatti ammettessimo cambiamenti nella sua potenza, allora Dio potrebbe fare diversamente da quello che fa, o aver potuto fare diversamente da quello che ha fatto, o aver potuto non fare quello che ha fatto o, ancora, poter cancellare quello che ha fatto: tutto ciò per cui si dice che Dio può ogni cosa e cioè anche fare il contrario di quello che ha fatto. Spinoza dice che questo è assolutamente impossibile. La dimostrazione, fatta per assurdo, si fonda sull’implicazione relativa alla natura di Dio a partire dagli effetti: siccome la natura di Dio è assoluta, se gli effetti prodotti da questa natura fossero diversi anche la sua natura dovrebbe essere diversa. Il fondamento dell’obiezione di Garber (secondo cui l’esistenza di Eunice non è spiegabile dalla natura data di Dio) è l’idea dominante secondo la quale Dio debba avere una volontà infinita: mentre cioè nell’intelletto infinito di Dio ci sono le idee di tutte le cose, la volontà non dà luogo all’attuazione di tutte le idee dell’intelletto ma soltanto ad alcune di esse. Solo sul presupposto che ci sia una volontà diversa e superiore all’intelletto è possibile chiedersi, come fa Garber, le ragioni del perché la natura sia così e non un’altra. Ma nel momento in cui questo presupposto non si dà, in quanto per Spinoza volontà e intelletto coincidono, la domanda di Garber diventa superflua e il principio di ragion sufficiente è fatto salvo.
Il confronto con la tradizione filosofica
Nell’ultimo capitolo vi è una discussione sull’eredità lasciata dal filosofo. Della Rocca sottolinea il grande impatto di Spinoza sul pensiero occidentale evidenziando però che, a differenza di altri grandi filosofi (Aristotele, Hume o Kant), egli non ha avuto una tradizione di pensiero equivalente tanto che in pochi sono oggi coloro che si identificano come spinozisti. La ragione di ciò è che «Spinoza’s philosophy functions as a challenge: almost all philosophers want to avoid his conclusions», ovvero ciò che abbiamo sottolineato recentemente con il nostro Tutti pazzi per Spinoza. But… Le conclusioni che discendono dalla sua filosofia e che molti evitano sono quelle maggiormente indigeste al pensiero dominante e al senso comune: il determinismo assoluto, la negazione del libero arbitrio, l’uguaglianza tra diritto e potenza, l’identità di intelletto e volontà, il timore di negare gli enti finiti in nome dell’infinito (“Spinoza non è ateo perché di Dio in lui ce n’è fin troppo” scrisse una volta Hegel). Proprio con quest’ultimo Della Rocca illustra un esempio che può illuminare. Nella Fenomenologia dello Spirito Hegel scrive che «Il vero è il tutto. Il Tutto però è solo l’essenza che si compie mediante il proprio sviluppo. Dell’Assoluto bisogna dire che è essenzialmente un risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità» ((F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, §§ 20)). Questo sarebbe inaccettabile per Spinoza per il quale l’Assoluto non ammette dentro di sé alcun divenire, tanto meno qualsiasi finalità. Della Rocca si domanda correttamente da dove deriverebbe la maggiore potenza che implica il considerare l’Assoluto un risultato, l’idea cioè secondo la quale Dio divenga più perfetto di quanto era prima. Le risposte possibili a questa domanda sono due: o la potenza viene da Dio oppure viene da fuori Dio. Entrambe le risposte però sono escluse: la maggiore potenza non può venire da Dio perché altrimenti essa già sarebbe in Dio il quale, a quel punto, non avrebbe necessità di diventare più potente; ma la potenza non può neppure venire da fuori Dio perché l’aumento di potenza in sé considerato costituirebbe un fatto bruto e questo, secondo il principio di ragion sufficiente (secondo cui nulla si produce da nulla), deve essere escluso in modo radicale. Risultato: non esiste in Dio alcun divenire, l’Assoluto non ha bisogno di alcun compimento.
Più controverso il rapporto con Nietzsche a cui Della Rocca dedica il maggior numero di pagine. Se da una parte il filosofo tedesco è a tratti irrisorio verso l’ebreo, dall’altra non mancano motivi che li accomunano. Quello principale è costituito dal fatto che Nietzsche riconosce che la ragione di Spinoza è l’affetto predominante, vera e propria espressione della volontà di potenza. In questo modo per Nietzsche, così come per Spinoza, guardare altrove per cercare valori è fare violenza alla propria natura (la quale consiste, per entrambi, nella realizzazione della potenza del proprio essere). Ma, come si è detto, altrettanto forti sono i motivi di inconciliabilità il principale dei quali è il prospettivismo nietzscheano (il fatto cioè che la verità è tale solo per i singoli punti di vista) contro l’oggettivismo spinoziano (la verità è una e non può essere che una).
La conclusione di Della Rocca è ancora una volta dedicata al PRS perché tutto ciò che Spinoza ha da dire nasce e muore con esso: «If we cannot demonstrate the power of PSR, then Spinoza’s philosophy can have no pull on us». E la potenza del principio consiste nella coerenza e nell’interconnessione con la quale esso lega qualsiasi aspetto della sua filosofia. In fondo, conclude lo studioso, nessuno desidera (soprattutto se si è filosofi) un pensiero minato da contraddizioni interne che ne compromettano stabilità e credibilità.