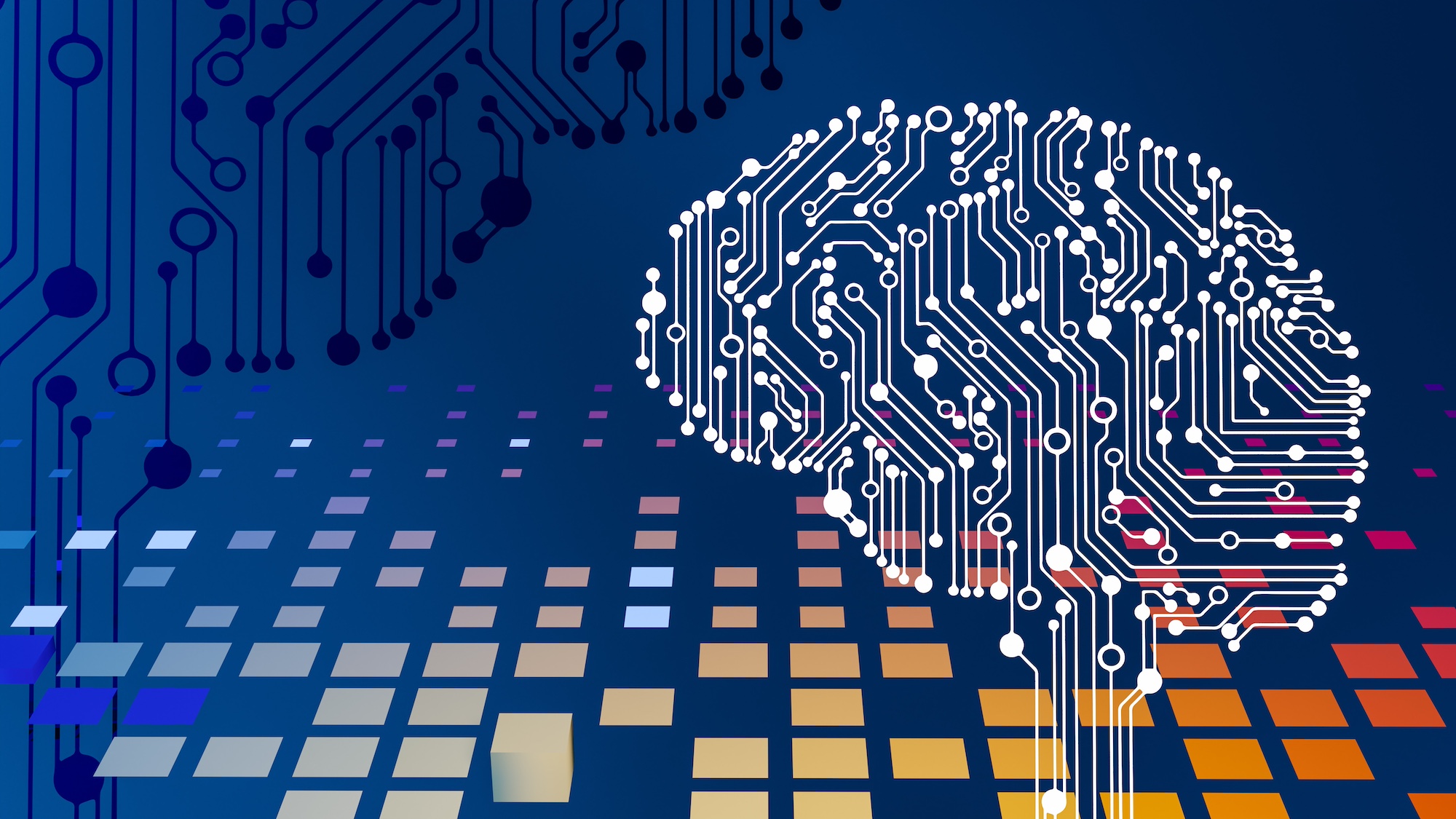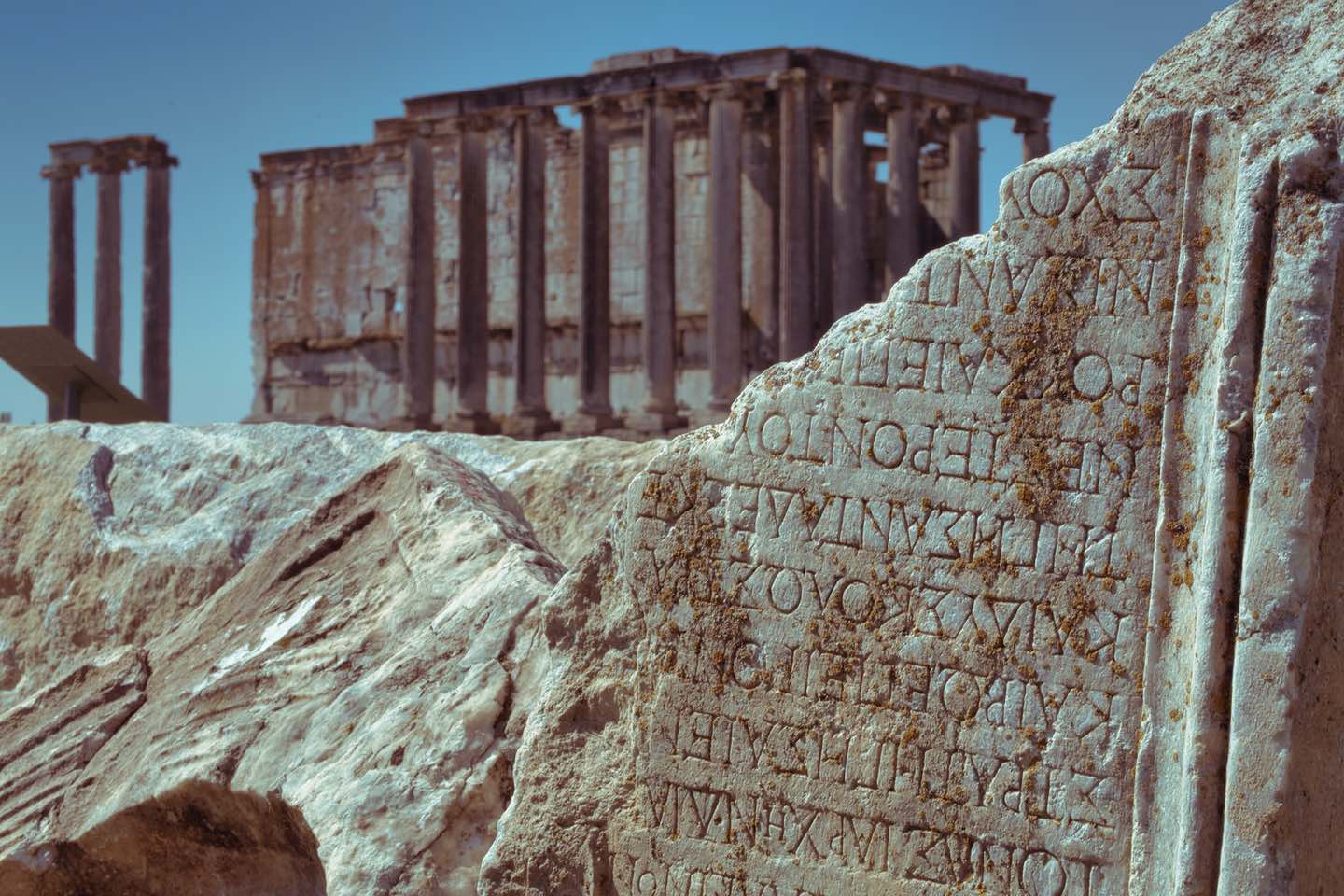Nella biografia pubblicata nel 2021 è stato definito The Contrarian, l’anticonformista. Non ha scritto libri di teoria politica ma per promuovere le sue tesi si affida soprattutto ai colloqui, più o meno accomodati e visibili su YouTube, che rilascia alla Hoover institution, un ente di politica pubblica americano. In un articolo apparso nel 2009 si definiva un libertario che «ha smesso di credere che democrazia e liberalismo siano compatibili».
Si tratta di Peter Thiel, 58 anni, brillante intellettuale e multimiliardario, fondatore di Paypal, presidente di un’azienda di intelligenza artificiale, sostenitore convinto dell’amministrazione Trump, verso la quale ha fornito numerosi uomini di sua fiducia, tra cui il vicepresidente Vance e l’inventore miliardario Elon Musk. Laureato in Filosofia a Stanford, Thiel è prima di tutto un imprenditore, un businessman, il cui successo ha aperto la strada alle sue idee filosofiche. In realtà si dovrebbero dire idee teologico politiche in quanto esse fanno riferimento in modo prevalente a quel lessico: bibbia, anticristo, apocalisse, katechon.
Thiel concentra in modo esemplare il suo credo teologico politico in un saggio del 2007 dal titolo The Straussian Moment. Nato come riflessione filosofica sul tema della violenza, l’articolo esamina lo sviluppo della civiltà occidentale in due direzioni: una filosofico- razionale e un’altra apocalittico-religiosa. Continue Reading