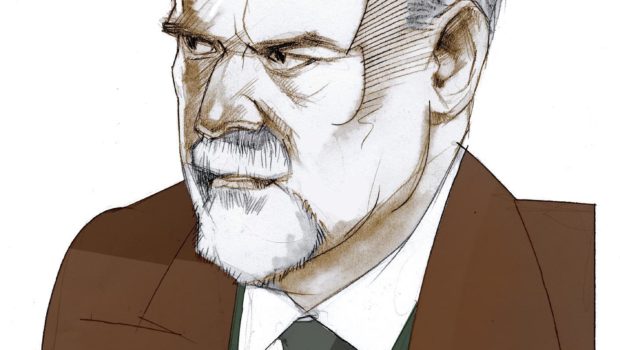Per comprendere la tesi di Heidegger in merito all’essenza dell’uomo bisogna partire dall’assunto che la soggettità (come il filosofo tedesco indica il principium individuationis) è un modo della dimenticanza dell’essere. Tale principio metafisico è all’origine del dominio, ovvero la modalità fondamentale dell’esistenza umana, che si realizzerà compiutamente nell’odierna età della tecnica. Chi ha affrontato seriamente i testi sa bene che quelli di Heidegger sono estenuanti, snervanti, a volte enigmatici. Ma non per questo sono eludibili se si tiene presente il fatto che il filosofo tedesco è il pensatore che ha tracciato il campo da gioco della filosofia contemporanea. Noi, che non siamo certo heideggeriani, riconosciamo però come egli sia stato una sorta di Cartesio della filosofia contemporanea da cui i filosofi successivi hanno tratto linguaggio e materia speculativa. Nei venticinque anni che vanno dalla prolusione universitaria Che cos’è metafisica? del 1929 al saggio Oltrepassamento della metafisica del 1954, Heidegger chiarisce a se stesso e ai suoi interlocutori il significato dell’essenza dell’uomo e della sua individuazione. Noi ne abbiamo ricostruito il percorso.
Ma l’Emanuele non fa la Grazia
Nonostante continui a chiarire che i suoi scritti non vanno verso la direzione del cristianesimo (così come ricorda anche nella recente raccolta dal titolo Dispute sulla verità e la morte), non mancano studi e interpretazioni che vogliono la filosofia di Emanuele Severino rivolta e comunque non distante da esso. Anche il recente convegno di studi organizzato per celebrare i 50 anni dalla pubblicazione della Struttura originaria (il libro da cui, secondo il suo stesso autore, dipendono tutti gli altri) ha ospitato alcune relazioni che hanno cercato di mettere in luce i fili per un dialogo tra il suo pensiero e il cristianesimo (vedi qui gli atti del convegno L’alba dell’eternità con download gratuito). Tra queste anche quella del nostro amico e collaboratore Marco Panteghini che abbiamo pubblicato su questo sito due settimane fa. In essa si domanda se l’esito del sistema di Severino possa rientrare nella dimensione della Grazia in quanto «il fatto che la contraddizione permanga insuperata, cioè sia di fatto insuperabile, non è in contraddizione con la superabilità della contraddizione stessa. Se allora la permanenza della contraddizione nella storia è possibile, non si dovrà dire che, se si ha l’avvento della Gloria della Gioia, esso è un accadimento di Grazia?». La nostra risposta a questo interrogativo, se abbiamo correttamente inteso il quesito, è negativa per le ragioni che andiamo ad illustrare di seguito.
Giordano Bruno, un pilota nell’universo infinito
Contro i sogni della scienza e della tecnica che oggi guidano le vite degli uomini, la filosofia non manca di ricordare che la conoscenza della natura e di ogni singolo fenomeno è legata in maniera imprescindibile alla conoscenza del tutto. Giordano Bruno è uno di quei pensatori che lo ha affermato nel modo più perentorio in quel luogo teoretico che, come abbiamo ricordato qualche settimana fa, concerne il rapporto tra l’uno e i molti, tra il particolare e l’universale. Tentare di ricostruire in poche righe la sua dottrina dell’individuo, e di quel particolarissimo individuo che è l’individuo umano, non è compito agevole: troppe le rielaborazioni simboliche, ontologiche, fisiche e metafisiche che si ritrovano nella sua filosofia, così come i rimandi polemici nei confronti di Aristotele, le cui dottrine Bruno padroneggia per denunciarne puntualmente limiti e aporie. Senza contare infine un metodo che, se spariglia e fa uso in maniera a volte spregiudicata di varie correnti filosofiche, ermetiche e religiose, è sempre finalizzato alla ricerca della verità. Nonostante questa congerie di elementi critici ci siamo tuttavia cimentati nel compito non solo per indicare alcuni tratti di un pensiero che rimane fecondo e denso di spunti ma anche per rendere il nostro dovuto omaggio al filosofo di cui abbiamo ricordato l’anniversario della morte avvenuta il 17 febbraio del 1600 a Campo de’ Fiori in Roma.
Uno, nessuno o centomila? Tutti e senza contraddizione
Il problema dell’individuo, della sua essenza, delle sue relazioni, della sua mortalità o immortalità fino alla sua eternità, discende da quella che è la questione più antica ed originaria della filosofia, ovvero il rapporto tra uno e molti, tra individuale e universale. Non esiste pensatore o tradizione filosofica che non abbia fornito o tentato almeno una risposta a questo problema. Così come non esiste discorso sull’umano, o preumano o postumano che dir si voglia, che non affronti in maniera implicita o esplicita tale questione senza che essa abbia ripercussioni sui concetti di Io, anima, mente, corpo, coscienza. Inaugurata da Parmenide e corretta da Platone con il ricorso ad immagini tratte dal mito, la questione del rapporto tra unità e molteplicità ha trovato la sua prima organica sistemazione grazie ad Aristotele che nella Metafisica ne fa l’architrave del suo sistema. Attraversando secoli di pensiero, Giovanni Gentile, nella Teoria generale dello Spirito come atto puro, ne fa il punto di partenza storico della sua riflessione per dimostrare come il problema sia risolvibile soltanto con il cambiamento dei presupposti di partenza.
The Imitation Game (Spinoza e l’educazione, II)
Uno degli aspetti più innovativi della visione antropologica di Spinoza è la dottrina dell’imitazione degli affetti introdotta nell’Etica in E3P27 in cui si afferma che «se immaginiamo che una cosa a noi simile, per la quale non abbiamo provato alcun affetto, sia presa da un qualche affetto, per ciò stesso siamo presi da un affetto simile». La proposizione dice due cose importanti. Prima di tutto che gli affetti sono il prodotto delle modificazioni reciproche indotte dal contatto tra corpi simili. In secondo luogo che gli affetti nascono prima di qualsiasi riflessione che gli uomini possano fare su di essi. Ciò dimostra che l’essere umano è determinato da un fascio di forze su cui non ha un immediato controllo e il cui gioco si svolge a prescindere dai suoi stati mentali. Con Spinoza, anche se così potrebbe non sembrare, ci troviamo agli antipodi di qualsiasi intellettualismo socratico. Altri filosofi e scrittori teorizzeranno l’imitazione degli affetti in vario modo. Hobbes e Shakespeare, per quanto riguarda il suo secolo, per passare da Hegel fino a giungere a René Girard, filosofo ed antropologo francese scomparso poco più di due anni fa, che l’indicherà con il nome di rivalità mimetica, desiderio del desiderio altrui.
Not so cool, Mr. Keating! (Spinoza e l’educazione, I)
Fin dalla sua nascita, l’educazione è sempre stata legata all’etica. Non esiste educazione se non nel guidare altri ad essere migliori e nel condurli ad una vita buona. Tema evidente in Platone, meno in altri filosofi. Uno di questi è Spinoza il quale tuttavia, scrivendo nelle pagine iniziali del Trattato sull’emendazione dell’intelletto che vero e sommo bene è la conoscenza dell’unione che la mente ha con la natura, sostiene che «si deve por mano – tra le altre cose – ad una filosofia morale così come a una dottrina relativa all’educazione dei fanciulli». Parole chiare, semplici, che legano in maniera indissolubile il pensiero di Spinoza alla pedagogia. Nonostante ciò, mentre abbondano gli studi di ontologia, di filosofia e teologia politica, pochi sono quelli che hanno messo a fuoco le implicazioni della sua filosofia con un tema decisivo come quello dell’educazione. A colmare in parte questa lacuna è stato un recente studio dal titolo Spinoza and Education, scritto da Johan Dahlbeck, ricercatore dell’Università di Malmoe in Svezia, con il sottotitolo Freedom, Understanding and Empowerment. Pubblicato all’inizio dell’anno appena trascorso, il libro è un utile filo conduttore per la discussione di alcuni temi centrali della ricerca educativa.
Corri Spinoza, corri!
Nell’ultimo numero di quest’anno, la rivista francese Le Magazine Littéraire (ora diventata Le Nouveau Magazine Littéraire) dedica una sezione speciale a Spinoza con contributi che prendono in considerazione i temi principali della sua vita e del suo sistema filosofico: dalle origini ebraiche ai rapporti con alcuni gruppi eretici cristiani; dalle posizioni politiche repubblicane fino all’analisi di alcuni temi come quello dell’obbedienza e della negazione del libero arbitrio; dai rapporti epistolari con amici e scienziati di tutta Europa fino al tentativo di costruire una lingua franca per promuovere un sapere accessibile a tutti. Il numero, esempio di ottima divulgazione unita a rigore scientifico, è espressione della ricerca storiografica della scuola francese a cui partecipano anche i nostri Proietti e Licata con un articolo sulle correzioni postume degli amici agli scritti in lingua latina del filosofo ebreo-olandese. L’ultimo articolo, a firma del filosofo Luc Ferry, espone infine una ragione sul perché non è possibile dirsi spinozisti. Essa s’incentra sull’argomento del carnefice: se noi dobbiamo amare il reale così com’è, ciò significa inevitabilmente amare i carnefici che inevitabilmente si trovano in esso. Il ragionamento viene espresso anche con un sillogismo retorico: «bisogna amare il reale così com’è, interamente, dire sì al fato; ma il fato include i carnefici: bisogna così amare anche i carnefici nella loro abiezione». Cosa evidentemente impossibile. Il filosofo sostiene di non avere incontrato nessun discepolo di Spinoza che sia stato capace di rispondere a tale obiezione, se non dichiarandola banale. Pur non essendo spinozisti di professione, proviamo noi a rispondere.
La tecnica scatenata e la decisione di essere uomo
Carl Schmitt è uno di quei filosofi “malfamati”, avrebbe detto Hegel, che in questi ultimi tempi stanno prepotentemente ritornando al centro del dibattito politico-filosofico. Una delle ragioni è semplice: Schmitt è pensatore che ha inserito al centro della sua riflessione la geopolitica, materia divenuta imprenscindibile per comprendere i pericoli mortali che si agitano dietro il teatrino costituito dai rapporti tra Stati e le loro continue minacce di guerra. Un modo per accostarsi al filosofo tedesco sono due brevi testi, pubblicati da Adelphi nel 2012 con il titolo Dialogo sul potere, che costituiscono in realtà la trascrizione di altrettante trasmissioni radiofoniche prodotte da una radio tedesca tra il 1954 e il 1955. Si tratta di due dialoghi, molto simili a vere e proprie rappresentazioni teatrali, nei quali viene discusso il potere nella sua essenza, nelle modalità con le quali vi si ha accesso e come si sviluppa sul piano dei rapporti di forza a livello internazionale.
Il padrone dipende dal suo cameriere
Il primo dialogo, che si svolge tra lo stesso Schmitt (indicato con C.S.) e un giovane (G.), verte sull’essenza del potere. Il potere esiste in quanto relazione di obbedienza tra gli uomini, ovvero tra coloro che proteggono e coloro che vogliono essere protetti. In questo modo s’istituisce la relazione tra governanti e governati nella quale, se è vero che i secondi sono sempre alla base della pretesa dei primi, è anche vero che i governanti riescono a plasmare e a guidare i governati nelle loro azioni e nei loro pensieri. In altre parole, se è vero che il consenso produce il potere, è anche vero l’inverso, ovvero che è il potere a produrre il consenso. Il risultato è che esiste un plusvalore, un residuo nel quale il potere trova una sua dimensione irriducibile a qualsiasi logica. Questo significa che il potere è autonomo anche rispetto ai potenti dando luogo ad una sua particolare dialettica che s’incentra sulle modalità di accesso alle informazioni. In questo modo se è vero che ha potere chi dispone delle informazioni, è anche vero che chi lo detiene si trova a sua volta dipendente nei confronti di chi è in grado di fornirle. Nasce così il fenomeno dell’anticamera, luogo in cui si agitano tutta una serie di influssi e poteri indiretti, sorta di corridoio che va dritto all’orecchio del potente. L’anticamera non può essere aggirata e al suo interno può esserci di tutto: uomini saggi ed intelligenti, sciocchi, arrivisti ed opportunisti. Il risultato di questa dinamica è che, quanto più il potere si concentra in un’unica persona, il potente diventa sempre più isolato. A quel punto, nota Schmitt, si verifica quel fenomeno tutto particolare per cui il potente, mentre perde i rapporti con coloro su cui esercita il potere, riesce a mantenere i contatti soltanto con chi riesce a dominarlo. «Non c’è eroe per il suo cameriere – scriveva Hegel nella Fenomenologia dello Spirito – e non perché quello non sia un eroe ma perché questo è un cameriere»: con tali parole il filosofo di Jena tracciava una dura fenomenologia a cui non si sottraggono quei politici particolari che sono i tiranni (ma la politica in fondo non è sempre una sorta di tirannia?); come dimostra la storia, i tiranni finiscono spesso in pazzia o per dipendere in modo irrazionale dalle donne (che siano le loro madri, mogli o concubine) come la letteratura e la stessa Bibbia insegnano (basti considerare a questo proposito l’episodio della vigna di Nabot in 1 Re 21 in cui Gezabele, moglie del re Acab, è di fatto la dispotica sovrana del regno). Emergono insieme a questo i casi di gestione grottesca del potere e il fatto che «nessun potere umano sfugge a tale dialettica di affermazione e negazione». Due sono gli esempi storici portati da Schmitt: le dimissioni di Bismarck del 1890 e il don Carlos di Schiller entrambi incentrati sulla questione su chi dovesse rendicontare ed avere accesso al sovrano.
Un’altra questione affrontata nel dialogo è quella relativa al problema se il potere sia buono, cattivo oppure neutro. In passato la questione era risolta a seconda delle prospettive ideologiche: se per il cristianesimo il potere, derivando da Dio, rimane nella sua essenza buono e divino, per un laico secolarizzato come Burckhardt il potere è in sé cattivo. Per Schmitt invece il potere è al di sopra della realtà ordinaria dell’uomo e, così come la tecnica, è sfuggito di mano agli uomini: la vera differenza risiede tra coloro che l’hanno e quelli che non ce l’hanno («il potere logora chi non ce l’ha», come si sarebbe cinicamente riconosciuto alle nostre latitudini). Secondo Schmitt, questa differenza tra il potere e l’impotenza ha collocato il concetto stesso di uomo entro un quadro problematico del tutto nuovo. Ora infatti lo scarto tra chi detiene il potere e chi non ce l’ha viene ad essere determinante per stabilire la sua natura, sicché la soluzione rimane nella constatazione che «nonostante tutto, essere uomo resta una decisione». Affermazione sibillina, quest’ultima, il cui senso viene chiarito nel dialogo successivo.
La Tecnica oltre il Nomos
Il secondo dialogo si svolge con tre personaggi. All’inizio Altmann (che rappresenta anche etimologicamente l’uomo tradizionale e lo stesso Schmitt) spiega a Neumeyer (figura dello scienziato) la dinamica fondamentale che contrappone terra e mare. Essa infatti risale niente meno che alla Bibbia la quale sin dall’inizio è impregnata di questa opposizione (anche in questo caso basti considerare il primo capitolo della Genesi). Il terzo personaggio in scena (Mac Future) sostiene però che la rincorsa allo spazio ha ormai sostituito terra e mare nell’appropriazione dei grandi spazi. In realtà obietta Altmann, non si vede nulla all’orizzonte che possa essere simile e corrisponda alle sfide delle scoperte geografiche all’inizio del XVI secolo. Oltrettutto, osserva lo pseudonimo del filosofo tedesco, «una verità storica è vera solo una volta ed in questo consiste il vero senso storico il quale ci ricorda l’unicità di ogni avvenimento».
Il problema di comprendere l’attuale fase storica è un altro e consiste nell’osservazione del contrasto tra est ed ovest come espressione di gradi e livelli diversi di industrializzazione: quello che decide insomma è lo sviluppo tecnico. Solo una volta riconosciuto ciò è possibile chiedersi come mai la rivoluzione industriale è avvenuta in Inghiterra, unica potenza marittima: la “tecnica scatenata”, come la definisce Schmitt, si associa con quella predilezione per il movimento che coincide con la capacità di andare per mare rispetto a quella terrena che preferisce la staticità della casa. Così come la tecnica moderna si è separata dalla nostra civiltà (come scrive Toynbee), così l’Inghilterra si è staccata dalla terraferma inaugurando l’epoca moderna. «La tecnica scatenata, più che aprire nuovi spazi all’uomo, lo chiude in gabbia – obietta Altmann – cosicché la sfida di oggi consiste nel saper dominare la tecnica».
Con queste parole, l’Epimeteo cristiano, così come si era autodefinito amaramente ricordando la sua esperienza di filosofo al servizio del nazismo (da cui aveva preso le distanze, dopo esserne stato minacciato, nel 1936), riassumeva il compito dell’uomo nei confronti della grande quanto spaventosa macchina neutralizzatrice. Compito che affonda le sue radici nella convinzione di Schmitt che l’uomo abbia un surplus di essenza rispetto alla tecnica. Convinzione che però non si avvede che l’uomo, prima ancora della decisione nichilista di essere un mortale, è un ente la cui nozione è massimamente confusa e così preda di qualsiasi volontà di potenza da cui scaturisce la più grande alienazione. Una decisione metafisica è alle radici della tecnica scatenata e della crisi della politica.
Dal tramonto della politica alla politica dell’eternità
Un primo livello costituito dal conflitto tra individui, stati, ideologie, religioni e tutto ciò che rientra nell’ambito della visibilità quotidiana. Sotto di esso il sottosuolo (secondo livello) costituito dalla verità (definita come fede) secondo cui le cose oscillano tra l’essere e il nulla, in termini ontologici la convinzione dell’agire libero da ogni immutabile grazie alla verità evidente del divenire. Ancora più sotto infine un terzo livello denominato di nuovo Sottosuolo (con la S maiuscola, vero e proprio sottosuolo del sottosuolo) che costituisce la negazione più radicale della convinzione del sottosuolo (con la s minuscola) in quanto mostra come il divenire è la Follia estrema e che l’eternità è ciò che costituisce lo spessore ontologico di ogni ente. Su questi tre livelli, come sanno i suoi lettori più fedeli, si gioca tutta l’opera di Emanuele Severino il quale ha saputo costruire con essi un’interpretazione della realtà che non ha pari nel panorama filosofico contemporaneo. La griglia è all’opera anche nel suo ultimo libro, Il tramonto della politica, che raccoglie i più recenti articoli e discorsi del pensatore insieme ad un’analisi inedita del pensiero di Carl Schmitt. Continue Reading
Careful with that axe, Thomas!
«Nessun procedimento intellettuale, per quanto chiaro, può spuntarla contro la forza di immagini autenticamente mitiche»: in questo rimprovero si concentra uno dei punti chiave del commento di Carl Schmitt al Leviatano di Hobbes. Il filosofo inglese avrebbe cioè utilizzato nella sua opera principale e più famosa un’immagine enigmatica, quella del mostro biblico, che ha di fatto contribuito a depotenziare la sua stessa teoria. Per Schmitt, Hobbes si è comportato come l’apprendista stregone che evoca spiriti che poi non è in grado di controllare. Anche se la sua immagine fosse il frutto di uno humor inglese non percepito, Hobbes non sarebbe stato saggio nel maneggiare un’arma così pericolosa come quella del mito. A Schmitt si potrebbe obiettare il de te fabula narratur visto che nel 1938, anno di pubblicazione di Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (come suona il titolo originale dell’opera), il filosofo e giurista tedesco era già stato pesantemente accusato e marginalizzato da quel nazismo a cui, pochi anni prima, aveva prestato il suo favore. Il saggio contiene comunque un groviglio di temi e di spunti di riflessione talmente densi che vale la pena dipanare, analizzare e, se possibile, chiarire.
Il mito biblico
Nei primi due capitoli Schmitt sottolinea la forza mitica di quest’immagine che non ha pari rispetto ad altre della filosofia politica. Tratta dalla Bibbia, essa ha fatto nascere una lunga serie di interpretazioni di cui due sono state quelle principali. Da una parte quella cristiana, dominata dal Leviatano come diavolo; dall’altra quella ebraica che nel mostro marino ha visto le potenze mondiali pagane a sé ostili. Scopo del Leviatano di Hobbes è invece completamente diverso e consiste proprio nel combattere una battaglia contro la teologia politica in ogni sua forma, nel tentativo di restaurare l’originaria unita vitale di religione e politica dopo la frattura, sediziosa e sovvertitrice per lo Stato, operata dagli ebrei. L’analisi di Schmitt parte dal significato del titolo e dal modo in cui esso si presenta nel libro. In primo luogo colpisce l’immagine del frontespizio che rappresenta un gigante, formato da piccoli uomini, che impugna nella mano destra una spada e in quella sinistra una tiara: nasce così subito una discrepanza tra quest’uomo artificiale e il mostro marino del titolo. Nel corso dell’opera, la parola Leviatano ricorre per di più solo in tre occasioni: una prima volta nell’introduzione, quando Hobbes equipara la civitas o respubblica ad una grande macchina; una seconda nel libro XVII, nel quale viene dedotta l’origine dello Stato dal terrore che costringe tutti alla pace; infine nel libro XXVIII dove domina il potere esecutivo che sottomette gli uomini attraverso premi e punizioni. Questa rarità nel ricorrere all’immagine del mostro biblico potrebbe essere dovuta, dice Schmitt, alla reticenza dell’autore di svelare integralmente il suo pensiero, «come di chi avesse timore ad aprire la finestra per paura della tempesta». In tutti i casi si tratta di un enigma non ancora sufficientemente chiarito dagli studi hobbesiani.
La macchina dello Stato
Nel terzo capitolo Schmitt ricorda come Hobbes definisca lo Stato un dio mortale, non tanto defensor pacis quanto piuttosto creator pacis. Il patto da cui trae origine non è di tipo comunitario ma ha carattere essenzialmente individualistico in una logica che non conduce alla persona ma alla macchina. Lo Stato è la machina machinorum, gigantesco meccanismo al servizio della sicurezza dell’esistenza fisica e terrena degli uomini. Con il trasferimento del concetto di macchina dall’uomo allo Stato, Hobbes compie il passo decisivo che rende possibile il processo di neutralizzazione culminante nella tecnicizzazione generale. Hobbes è il pensatore con il quale s’inaugura l’età della tecnica. La verità e la giustizia di questo Stato consistono nella perfezione dei suoi automatismi, sicché si deve dire (prescindendo da ogni giudizio di valore) che questa macchina o funziona o non funziona. In questo modo la distanza che separa lo Stato tecnico neutrale dalla comunità medievale è irriducibile. Se per quest’ultima esiste un diritto di resistenza contro un governante illegittimo, nello Stato assoluto il diritto di resistenza non solo è praticamente impossibile ma non esiste nemmeno come problema: o questo Stato esiste in quanto tale (e allora funziona in modo inarrestabile) oppure non esiste (e allora torna lo stato di natura). La contrapposizione tra Stato e comunità medievale si rivela anche nel diritto internazionale dove non ha più senso apporre l’aggettivo di “giusta” alla guerra la quale, diventata ormai un affare di Stato, è sempre totale dal momento che nel diritto internazionale si fronteggiano quei particolari individui chiamati Stati che vivono loro stessi in un reciproco stato di natura.
Distinzione tra interno/esterno e crollo dello Stato
Il nodo cruciale però consiste in quella distinzione tra coscienza individuale e coscienza pubblica che costituisce, secondo Schmitt, il punto di rottura della teoria hobbesiana (da qui il sottotitolo del saggio, significato e fallimento di un simbolo politico). L’aspetto viene trattato nell’ambito della questione dei miracoli. Secondo Hobbes è miracolo ciò che lo Stato vuole che si creda sia tale, sicché il dio mortale ha potere su di esso e sulla confessione di fede. Tuttavia il diritto di esigere la confessione si limita alla lingua, cioè alla dimensione esteriore dell’individuo, lasciando la fede interiore fuori da ogni coercizione. Questa riserva è ciò che condurrà, secondo Schmitt, alla distruzione del potente dio mortale, in quanto la distinzione tra fede pubblica e fede privata condurrà, da una parte, alla libertà di pensiero e di coscienza e, dall’altra, all’origine dello Stato neutrale e agnostico. Nel momento in cui la distinzione è posta, la superiorità della coscienza sullo Stato è in sostanza cosa già decisa. Questo germe sarà portato a pieno sviluppo da Spinoza, il primo ebreo liberale della storia. Se infatti nella dottrina di Hobbes la pace pubblica e il diritto del potere sovrano hanno sempre la priorità, in quella di Spinoza viene al primo posto la libertà di pensiero con la pace pubblica e il diritto del potere sovrano che si trasformano in semplici riserve. Lo Stato assoluto può esigere tutto ma solo esteriormente e la religio si trasferisce nella sfera privata dell’individuo. Sarà con un altro ebreo, Moses Mendelssohn alla fine del XVIII secolo, che il principio della separazione interno/esterno si radicalizza grazie a quello che viene definito da Schmitt (non senza una punta di antisemitismo) «l’infallibile istinto ebraico di minare e scalzare la potenza dello Stato, il mezzo migliore per paralizzare il popolo dei gentili e per emancipare il proprio».
Nascita del liberalismo e seconda morte dello Stato ad opera dei poteri indiretti
Ma, oltre a quelle già citate, un’altra tesi emerge dal saggio del filosofo e giurista tedesco: quella secondo cui Hobbes è un antenato delle costituzioni borghesi. Tale tesi si giustifica in primo luogo perché il filosofo inglese ha anticipato la concezione costituzionale dello Stato di diritto fondato su un patto; in secondo luogo perché ha trasformato il concetto di legge, intesa ora come una motivazione coattiva psicologicamente calcolabile, nella possibilità di costrizione all’obbedienza secondo termini che saranno poi definiti da Weber. Questi elementi presenti nella dottrina hobbesiana sono sempre stati misconosciuti tanto che il suo autore è stato comunemente dipinto come colui che ha anticipato lo Stato totalitario con i suoi terrori e le sue atrocità. In realtà ad Hobbes interessa superare l’anarchia di diritto e di resistenza feudale istituendo un potere centralizzato che ha il solo obbligo di protezione del bene assegnatogli, la vita degli individui. Se cessa la protezione, cessa anche lo Stato e l’individuo riguadagna la sua libertà naturale. La relazione di protezione e obbedienza, fatta poi valere nello stato di leggi positivistico dell’800, è così la pietra angolare della dottrina di Hobbes, vero e proprio pioniere dello Stato liberale.
Tuttavia proprio questo principio (a sua volta derivante dall’originaria distinzione della coscienza interna da quella esterna) è la malattia che conduce il dio mortale ad una seconda morte inflittagli da tutte quelle potenze anti-individualistiche (chiese, partiti, sindacati) che, in nome della libertà individuale, si sono spartite le sue carni. La requisitoria di Schmitt è qui durissima. Il dualismo di Stato e società libera ha generato un pluralismo sociale nel quale hanno prevalso i cosiddetti poteri indiretti, cioè quei poteri che non agiscono a proprio rischio ma per il tramite di altri. Scrive Schmitt che «la sfera privata, presunta libera, garantita da questo sistema costituzionale, fu così sottratta allo Stato e consegnata ai poteri liberi (cioè incontrollati e invisibili) della società». Hobbes aveva compreso che «i pericoli che minacciano l’individuo, provenienti dalle Chiese e dai profeti, sono peggiori di tutto ciò che si può temere da un’autorità statale e temporale», ma il suo simbolo politico ed insieme il suo insegnamento è fallito. Ciò non toglie che il magistero del filosofo inglese non sia stato vano, come gli grida dietro il suo recensore nelle parole conclusive («non jam frustra doces, Thomas Hobbes»), secondo lo stile di chi è solito discutere coi grandi spiriti del passato.