La filosofia, come diceva Deleuze, ha sempre a che fare con il pensiero comune. Non solo perché è necessario porre in questione le certezze che indirizzano l’ampio agire umano, ma anche perché a volte quello stesso pensiero comune (doxa) è guidato da convinzioni filosofiche, scientifiche, tecniche. In un processo di auto-correzione, potremmo dire, la filosofia è per statuto impegnata a problematizzare la realtà e lo strato più superficiale rappresentato da ciò che noi definiamo come realtà. Infatti, è sempre la filosofia che ha l’onere di occuparsi di quello spazio che Berger e Luckmann definivano “proprio” della sociologia della conoscenza (Berger-Luckmann 1966). Astraendo dall’interpretazione teoretica, i due sociologi si concentravano su un livello diverso e complementare. Perché, scrivono: «Le formulazioni teoretiche della realtà, siano esse scientifiche o filosofiche o anche mitologiche, non esauriscono ciò che è “reale” per i membri di una società. Tenendo presente questo fatto, la sociologia della conoscenza deve anzitutto occuparsi di quello che la gente “conosce” come “realtà” nella vita quotidiana a livello pre-teoretico o non-teoretico. In altre parole, il principale centro d’interesse della sociologia della conoscenza deve essere la “conoscenza” del senso comune piuttosto che le “idee”» (Berger-Luckmann 1966, p.30).
Tuttavia, nella misura in cui la filosofia mette in discussione le radici su cui poggia il “reale” di Berger e Luckmann, anche questo viene immediatamente messo in discussione e ritradotto. Il processo di problematizzazione, inoltre, può avvenire sia dall’alto che dal basso, ovvero dalla realtà o dai suoi fondamenti. Sarebbe sciocco pensare che la filosofia si debba occupare solo dei fondamenti e mai delle “storture” che la realtà accoglie. È grazie a un atteggiamento come questo che la filosofia si è isolata, si è resa congettura vana e puramente speculativa. Il senso vero del filosofare – ben prima di essere, con Hadot e gli antichi, una pratica – è gettare luce sulla strada e indirizzare i passi. Se non fa (anche) questo l’infondato prende il largo e piazza le tende, si autoalimenta e diventa pensiero egemone.
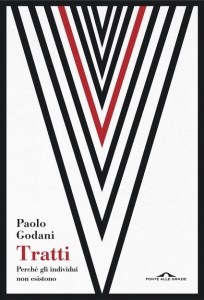
È dentro il modo “antico” di fare filosofia che, invece, si pone Paolo Godani. Lo aveva fatto già nei suoi precedenti lavori sull’economia e l’etica del desiderio, ma soprattutto con quanto andava tratteggiando ne La vita comune (Godani 2016). Già lì, paragrafando il sottotitolo, Godani provava a immaginare «una filosofia e una politica oltre l’individuo»; ma è con l’ultimo suo volume che questa traccia si mostra in tutta la sua forza. In Tratti. Perché gli individui non esistono (Godani 2020) – versione italiana di un testo prima uscito in Francia, presso l’editore PUF di Parigi – Godani mostra come il concetto di “individuo” non solo non esiste ma che la sua accettazione a-critica è il fondamento di alcuni errori filosofico-politici che invece accogliamo senza grandi disquisizioni.
Nel lessico filosofico, soprattutto quello di matrice post-cartesiana, l’individuo è «un’entità unica e irripetibile» (Godani 2020, p. 16), è la matrice compatta che – ontologicamente distaccata dal mondo e dall’esperienza – concentra su di sé tutta l’attenzione, la responsabilità e la potenza dell’esperire. L’individuo – che nella sua accezione “umana” è anche politicamente riconosciuto secondo queste caratteristiche – è dunque ciò che si distingue dall’altro, dalla cosa; è, in altre parole, in tanto quanto non è tutto il resto, è l’insieme delle sue determinazioni quantitative. Per mostrare l’inconsistenza di questa scissione e per descrivere invece la natura continua dell’essere e delle entità che lo popolano, Godani compie un lungo tragitto che a partire dall’essenza qualitativa degli oggetti che conosciamo, la loro singolarità e non individualità, ci mostra l’esistenza piuttosto di «tratti». Un «tratto», se non viene assolutizzato e reso individuo, è una qualité marquante, una qualità ben chiara che si somma a un’infinità di ulteriori stimoli che verranno poi collocati in un quadro più ampio e astratto. La terza parte del libro, la più godibile anche alla lettura, si concentra sull’insieme di questi tratti, sulle «costellazioni» che – sebbene si mostrino chiaramente come singolari – non possono mai definirsi «individui», cioè irripetibili e unici.
«I tratti, infatti, hanno sì una natura qualitativa, ma non sono pensieri, né entità meramente ideali. Sono le differenze ultime che costituiscono l’essere stesso in quanto molteplicità» (Godani 2020, p. 15).
Godani, quindi, applica all’esperienza e alla realtà dell’esperienza, uno sguardo comprensivo, non viziato dalla necessità aristotelica di rintracciare i confini di ciò che è, dell’ente. È infatti il modo di intendere l’esperienza a cambiare radicalmente. Godani si pone nella prospettiva rivoluzionaria che Bergson aveva tracciato nel suo Materia e memoria, perché è lì che l’autore francese prospettava la fine della percezione per come l’abbiamo intesa per secoli. In Materia e memoria Bergson disegna la possibilità di una conoscenza intermedia fra la percezione dell’individuo e la concezione del genere a cui l’individuo appartiene. Per dirla in altre parole: non siamo Io che percepiscono il Mondo, siamo percezioni continue sulla realtà, mescolanza indeterminabile. Le determinazioni dell’essere sono tali nella misura in cui prevedono il loro immediato oltrepassamento. Un tratto, in quanto singolarità qualitativa, non appena viene identificato è subito ricompreso in una costellazione, dice Godani, «che travalica i confini della divisione specifica. […] Una costellazione di tratti sarà così una composizione auto-consistente di determinazioni elementari. […] Con le costellazioni di tratti ci troviamo fuori dalla mera divisione del concetto, senza che ciò implichi la necessità di appellarsi a qualche misterioso elemento non qualitativo capace di rendere le costellazioni irripetibili» (Godani 2020, p. 81-82).
Molte delle certezze che muovono il nostro agire e pensare nel mondo nascono nel recinto segnato dal concetto di individuo. Eliminare ciò che ci ha portato a riconoscerci come “autonomi” rispetto a tutto, non corrisponde a un depotenziamento. Al contrario: «liberarsi del misticismo delle entità senza senso significa liberarsi del mistero dell’individuo ineffabile. Significa, in secondo luogo, ripensare, al di là dell’idealismo, la co-appartenenza essenziale dell’essere e delle sue determinazioni» (Godani 2020, p. 145). Sotto questo punto di vista, quindi, che risente in modo evidente delle influenze severiniane, anche la morte assume una connotazione diversa. La morte, a cui Godani dedica l’ultima intensa parte del libro, è relativizzata, è assunta interamente all’interno della vita, poiché – con Spinoza e Mach, ma anche con Whitehead – si abbandona la convinzione per cui la morte si oppone alla vita dell’Io che la deve rifuggire. La vita, invece, «è punteggiata da mille piccole morti quotidiane, morti del corpo, degli organi, dei ricordi, delle percezioni, degli intenti e delle promesse» (Godani 2020, p. 223). Ma quel che è più importante è che queste singolarità non sono se non entro una cornice che non appena viene definita sfugge, si ampia, muta e permane. Infatti, come scrive Godani: «queste mille disparizioni non implicano la caduta nel nulla dei contenuti della vita, degli elementi che attraversandola la costituiscono» (Ibidem). Sub specie temporis le cose individuali muoiono e si addentrano nell’oblio; nello sguardo della natura invece questi individui che noi identifichiamo e proviamo a fotografare si manifestano come tratti o costellazioni di tratti, elementi essenziali che «semplicemente appaiono e scompaiono, senza che ciò possa significare che essi appaiono e scompaiano una volta per sempre» (Godani 2020, p. 224).
Il testo di Godani si propone di affrontare una questione metafisica intorno agli individui; è una ricerca preliminare a molte altre e che pone le basi di una riconversione del modo di intendere il mondo e i rapporti fra “le cose”. Paolo Virno ha scritto a ragione che «questo libro divide la filosofia italiana in un prima e un dopo»; sì, perché Godani fa sintesi di numerose riflessioni filosofiche e porta all’emersione di una questione troppo spesso sottovalutata. Non c’è necessità solo di capire come gli uomini intendano la «realtà», per riprendere le riflessioni di Berger e Luckmann; è inevasa e inesauribile la necessità di capire lo strato teoretico che conduce alla creazione di un determinato modo di intendere la «realtà».
Riferimenti bibliografici
– Berger, Pether e Luckmann, Thomas. 1966. La realtà come costruzione sociale. Bologna: Il Mulino.
– Godani, Paolo. 2016. La vita comune. Per una filosofia e una politica oltre l’individuo. Roma: DeriveApprodi.
– Godani, Paolo. 2020. Tratti. Perché gli individui non esistono. Milano: Ponte alle Grazie.
Photo by Clay Banks on Unsplash

