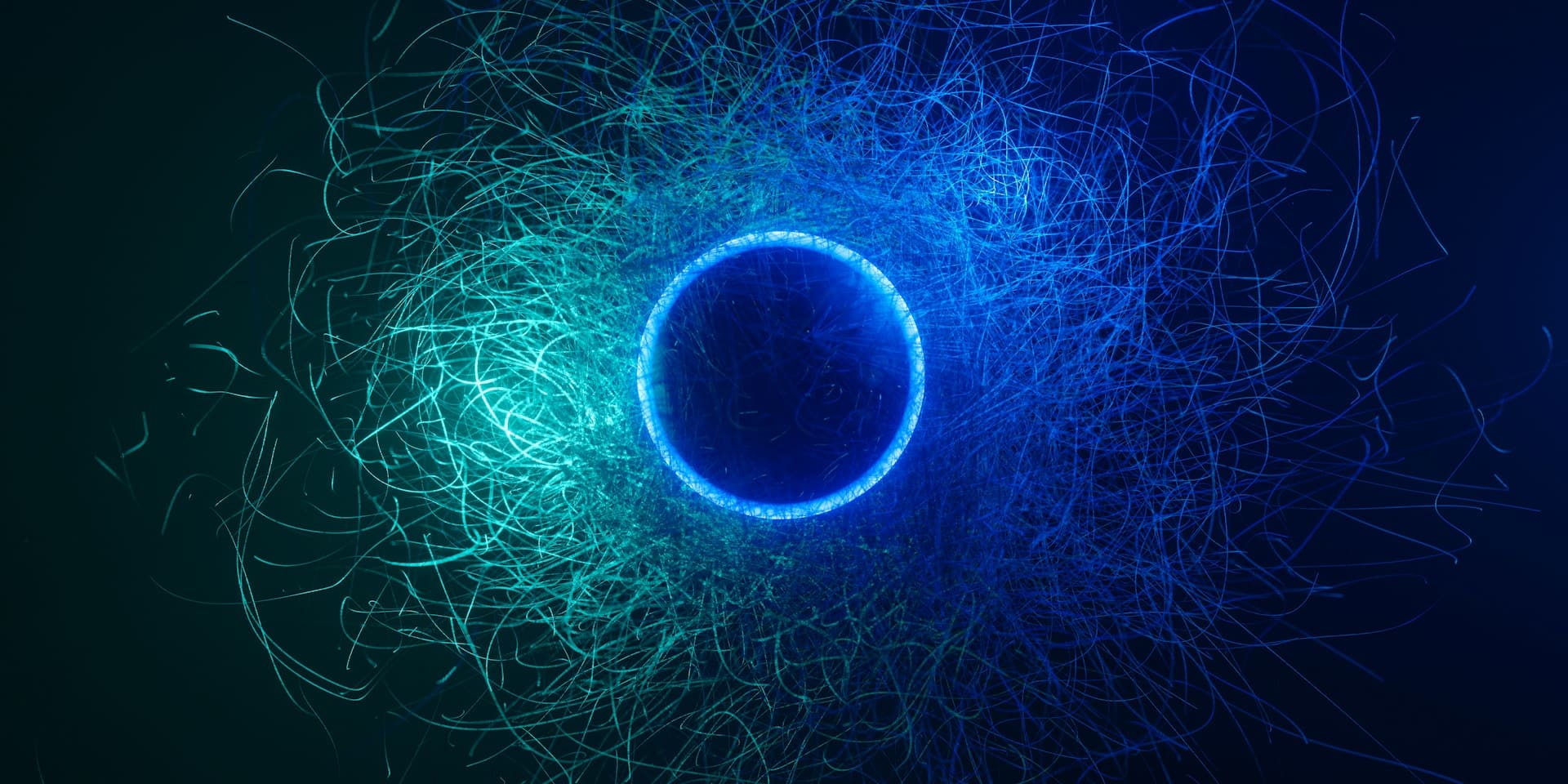Questo articolo è frutto del lavoro congiunto di Alessandro Lattuada e Aldo Pisano entrambi componenti della Redazione di Ritiri Filosofici. L’articolo è il secondo di una serie di tre contributi che intendono prendere ad esame il rapporto tra filosofia e fisica seguendo le tracce del lavoro del fisico Carlo Rovelli.
___________________
«La gravità può attraversare le dimensioni. Compreso il tempo».
Joseph Cooper, Interstellar, 2014
Natura facit saltus: contesto e profilo storico della meccanica quantistica
Riuscire ad esprimere con estrema linearità e chiarezza lo sviluppo della meccanica quantistica è di fatto un’impresa ardua. Fondamentalmente per due ordini di motivi: il primo è che essa segue uno sviluppo storico-cronologico di più di un quarto di secolo, in cui è coinvolta una buona parte dei grandi fisici e scienziati dei primi trent’anni del ‘900; il secondo motivo è che la meccanica quantistica rimane tutt’ora difficile da comprendere nei suoi processi fondamentali. Tale irrimediabile constatazione deriva dal fatto che, quando prese avvio lo studio delle particelle e quindi del mondo microscopico, il risultato fu quello di un sempre maggiore e successivo scandaglio delle componenti prime della realtà fisica, quindi della struttura stessa della materia. Da questi successivi e continui svisceramenti della struttura fisica del reale, tutt’ora in atto, si è tentato di derivare un formalismo matematico che potesse mettere insieme una teoria quantistica in uno strutturato sistema di leggi. Ciò non è stato possibile. Ancora oggi, più si va in profondità e più i meccanismi sfuggono, più si ricerca, più si assiste all’affermarsi del caso sulla necessità. Tuttavia, l’effetto sorprendente di tutto ciò è che, sebbene non esista un modo per sistematizzare in senso definitivo il comportamento delle particelle quantistiche, gli effetti pratici e tecnologici che da esse derivano sono paradossalmente funzionanti. In sintesi: la meccanica quantistica è una teoria che funziona, ma che ancora non si riesce a comprendere, e che tutt’oggi continua ad essere indagata, ridefinita in una vasta pletora di interpretazioni. Esistono dei naturali limiti storici e intellettuali nella possibilità di una ricostruzione complessiva della teoria, che spesso e volentieri si nutre delle biografie e degli scritti diretti di coloro che svilupparono la teoria agli inizi del ‘900 (Kumar 2010).
Continue Reading