 Carlo Rovelli
Carlo Rovelli
Sette brevi lezioni di fisica
Adelphi, 2014, pp. 88
Perché un sito di filosofia dovrebbe parlare di un testo nel quale un famoso fisico, Carlo Rovelli, ci racconta in modo breve, conciso e divulgativo, cosa è accaduto nella fisica del XIX e XX secolo? La risposta è semplice: la fisica e la filosofia sono sempre andati a braccetto, hanno sempre vissuto vicino, fino a coincidere in alcuni momenti. Anzi, la filosofia si è presentata – nella madre patria Grecia – prima come una scienza della Physìs e poi come il tentativo di oltrepassare quella scienza, attraverso la meta-fisica.
Fin qui siamo stati scolastici, quasi liceali.
Anche il libricino di Rovelli ha il pregio di essere scolastico, perché ha la capacità di presentare cose difficili per chi non è avvezzo alla fisica, in modo chiaro e fruibile attraverso diversi piani di profondità: si può insomma leggere lo stesso capitolo con concentrazione diversa.
Le lezioni passano da La più bella delle teorie (ovvero la relatività di Einstein), per presentare gli sviluppi di essa, l’altra grande teoria della fisica del XX secolo (la meccanica quantistica), spiegando lo stupendo paradosso secondo il quale la relatività e la meccanica quantistica siano opposte l’una all’altra, eppure convivono in modo pacifico spiegando il mondo e l’universo in modo complementare. Ci spiegano (lezione terza) la struttura del cosmo, che durante la storia del pensiero si è sempre di più allargato, fino ad essere concepito come davvero infinito e pieno di altre galassie molto più grandi delle nostre. Tutto ciò comporta una rimodulazione delle nostre tesi sul materia, spazio e tempo, che vengono evidentemente ridefinite. Lo studio, in particolare, della probabilità e dei buchi neri (lezione quinta) pongono ai fisici delle questioni relative al tempo che potrebbero portare ad affermare la non-esistenza del tempo per come lo intendiamo noi. Un’idea che sembra folle e controintuitiva, appena accennata da qualche filosofo all’inizio del Novecento (penso a Bergson) che, non a caso, era fortemente legato alle vicende della fisica e dell’epistemologia del tempo. Scrive Rovelli: «fisici e filosofi sono arrivati alla conclusione che l’idea di un presente comune a tutto l’universo sia un’illusione, e lo “scorrere” universale del tempo sia una generalizzazione che non funziona» ((p. 65)).
Ma il capitolo più interessante è certamente l’ultimo, intitolato “Noi”. Si tratta di una piccola riflessione di Rovelli sul ruolo che l’uomo ha e continua ad avere in questo universo fisico. Si tratta di tornare dal macrocosmo universale al microcosmo dell’uomo che si pone in costante rapporto con la natura e l’universo. Una natura ed un cosmo, dice Rovelli, che hanno regole ben precise a cui rispondono, e «non c’è nulla in noi che violi il comportamento naturale delle cose. Tutta la scienza moderna, dalla fisica alla chimica, dalla biologia alle neuroscienze, non fa che rafforzare questa osservazione» ((p. 78)). Nonostante ciò Rovelli ha il pregio di non voler dare ricette eterne, sa bene che la scienza cammina su delle palafitte, come diceva Popper, e non ha né potere predittivo né taumaturgico .
Ma si chiede anche come possiamo far convivere il nostro sentimento di libertà nell’azione e nella decisione, con una natura che se ne frega delle nostre decisioni? A questa domanda Rovelli risponde attraverso la «lucidità meravigliosa» ((p. 79)) di Baruch Spinoza. Dice l’autore: «sarebbe assurdo chiedersi se “io” posso fare qualcosa di diverso da quello che decide di fare il complesso dei miei neuroni: le due cose, come aveva compreso con lucidità meravigliosa nel XVII secolo il filosofo olandese Baruch Spinoza, sono la stessa cosa. Non ci sono “io” e “i neuroni del mio cervello”. Si tratta della stessa cosa» ((Ivi.)). E quindi non esisto io e (separatamente da me) la natura. Io sono parte integrante della natura; una parte che pensa e che ha una capacità elaborativa straordinaria nel cervello che non riesco (sempre) a calcolare e prevedere. Ma è bene ricordare che «quanto è specificatamente umano non rappresenta la nostra separazione dalla natura, è la nostra natura» ((p. 81)).
Su quest’inno al Tutto, potremmo dire, si chiude il piccolo libro di Rovelli che esplora le più grandi teorie fisiche dei due secoli passati, ma in fondo si tiene ancorato a quell’intuizione antica secondo la quale l’uomo non è nient’altro che una parte minuscola della natura, capace di guardare in faccia, con meraviglia, ciò che non sa.


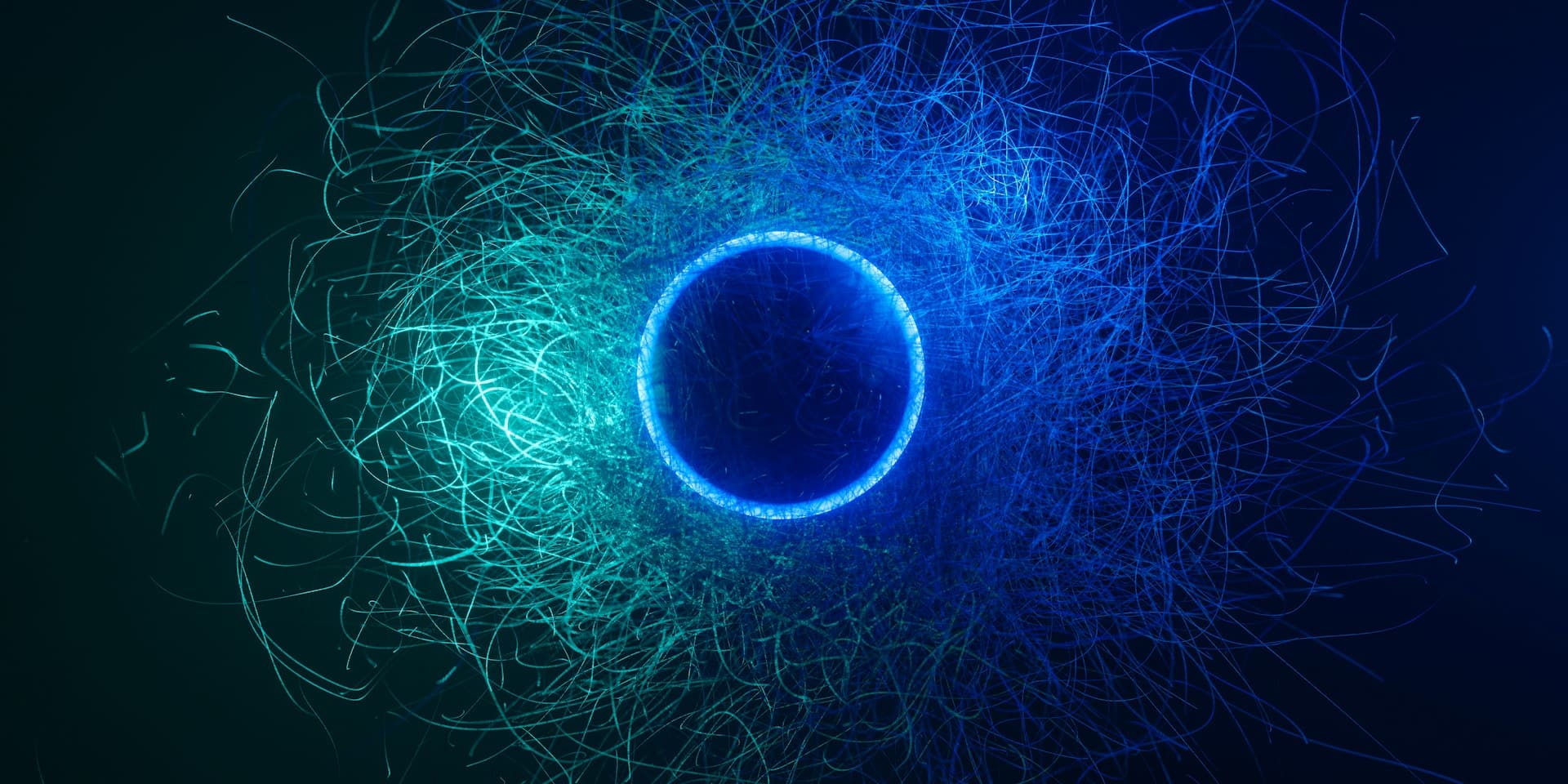





 Carlo Rovelli
Carlo Rovelli