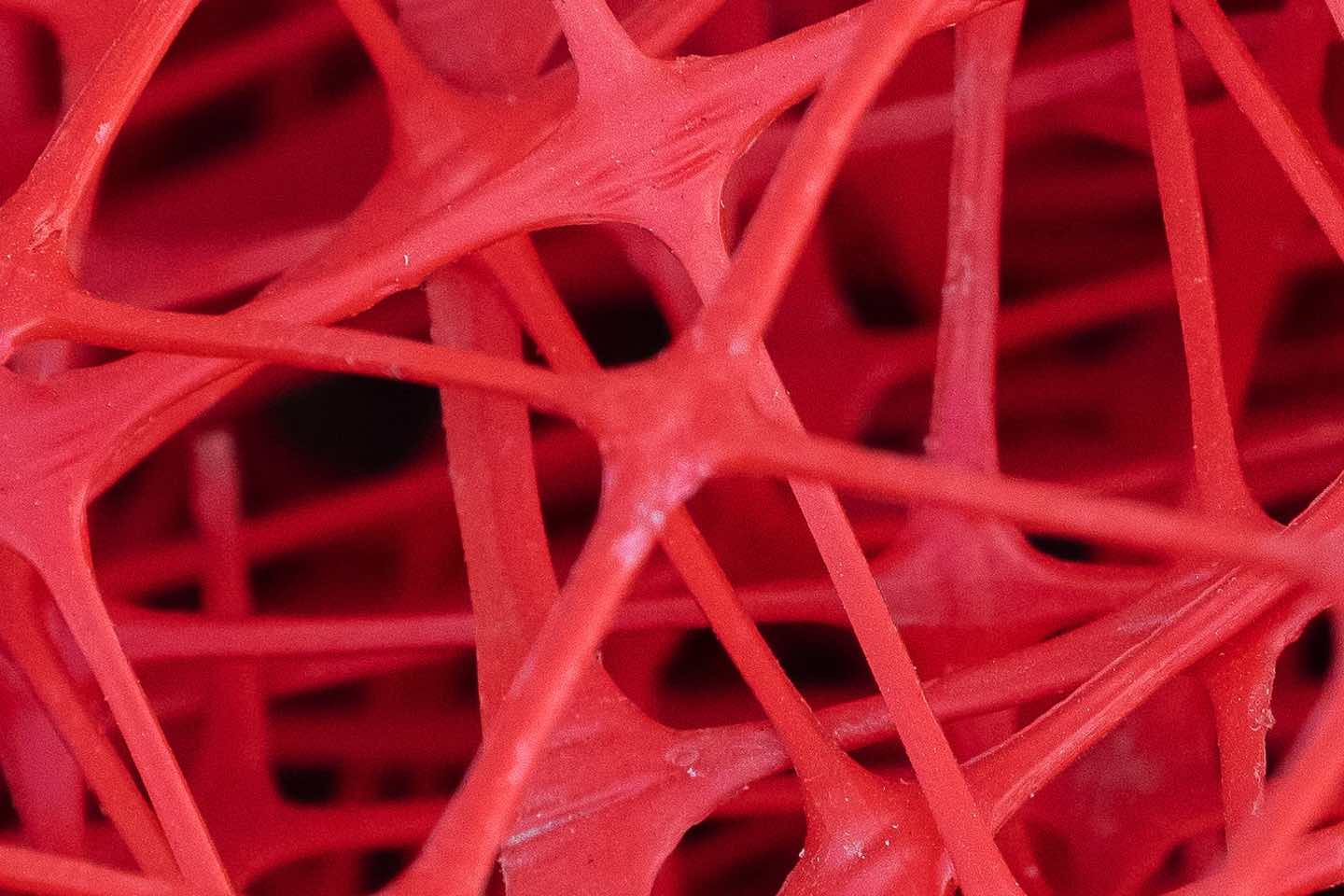Segnaliamo con grande piacere la pubblicazione di un saggio di Simone Aurora, ricercatore presso l’Università di Padova, dal titolo Il campo della coscienza. Aron Gurwitsch e la fenomenologia trascendentale, uscito per Orthotes nel 2022. Il contributo è di assoluta rilevanza all’interno del nostro panorama culturale dal momento che ha il singolare merito di introdurre il lettore italiano all’opera – e alla vicenda biografica, raramente come in questo caso – del filosofo lituano Aron Gurwitsch, vissuto tra il gennaio del 1901 e il giugno del 1973, attivo soprattutto in Germania e in Francia a cavallo tra i due conflitti mondiali e poi negli Stati Uniti. Continue Reading
Uno sguardo eretico su Merleau-Ponty
Maurice Merleau-Ponty. L’apparire del senso, uscito nel 2024 per la collana «Eredi« di Feltrinelli (Taddio 2024), è l’ultimo libro di Luca Taddio, professore associato presso l’Università di Udine: un testo introduttivo – ma non divulgativo – al pensiero del fenomenologo francese e della panoramica dei suoi molteplici campi di indagine. In questo studio, Taddio si impegna a ripercorrere per intero gli snodi concettuali del pensiero di Merleau-Ponty a partire dalla prima apparizione de La struttura del comportamento, titolo risalente al 1938, sino a Il visibile e l’invisibile, l’ultima opera rimasta purtroppo incompiuta e che sarebbe stata edita in Francia solo nel 1964, vale a dire a tre anni dopo la prematura scomparsa del filosofo. Per Taddio si tratta del coronamento di una riflessione ventennale sul pensiero fenomenologico, dalle sue origini sino ai suoi approdi più originali e forse insperati, come del resto attesta l’ampiezza della sua odierna produzione scientifica.

Il libro di Taddio si inserisce in un filone interpretativo di per sé vasto all’interno del nostro paese, che da sempre ha riconosciuto una particolare attenzione, quando non favore, all’opera di Merleau-Ponty; questo almeno a partire dalla mediazione apportata da Enzo Paci negli anni Cinquanta, pioniere italiano del movimento fenomenologico di seconda generazione. Da allora numerosi interpreti e filosofi italiani hanno infatti dedicato a Merleau-Ponty una lettura attenta, uno sguardo interessato, un momento di riflessione quasi mai occasionale. Su tutti, mi piace ricordare il testo di Luca Vanzago, Merleau-Ponty che usciva per Carocci nel 2012, e del quale il lavoro di Taddio si pone in proficua scia concettuale (Vanzago 2012). L’apparire del senso non propone però, in questo caso e in primo piano, una ricostruzione storica del percorso intellettuale di Merleau-Ponty – nonché della sua trasformazione da fenomenologia della percezione a ontologia della carne – ma predilige un approccio più diretto e puntuale alle questioni teoriche che via via si propone di affrontare, di risolvere, o di mostrare al pubblico contemporaneo secondo una nuova luce. L’originalità del testo sta proprio in questa particolare scelta stilistica e ermeneutica, molto apprezzabile, che fa rivivere le classiche questioni merleau-pontyane nel confronto con le sfide o gli interrogativi più cogenti del nostro tempo, appoggiandosi con competenza a quesiti di filosofia della scienza o della tecnologia più attuale e stringente. Si tratta di un approccio già perseguito da Etienne Bimbenet, in Francia, e che ha consentito di riproporre quando non introdurre alcuni tratti del pensiero merleau-pontyano nel dibattito scientifico contemporaneo, e di farlo con coerenza (cosa affatto scontata). Anche Taddio dà così nuova linfa al testo di Merleau-Ponty attestandone il carattere di fondamentale apertura e di sempre rinnovata interrogazione, all’interno e oltre gli stilemi interpretativi del suo tempo e del nostro presente.
Merleau-Ponty fu lettore di Husserl, nonché commentatore attento e interessato degli esperimenti condotti dalla psicologia della Gestalt dei primi decenni del Novecento, delle considerazioni della biologia evoluzionistica, ma anche, più prosaicamente, amante del teatro e della letteratura, come l’amico-nemico Jean-Paul Sartre. La poliedricità dei suoi interessi traspare pienamente nei suoi lavori, nei riferimenti che li impreziosiscono, e negli intenti che li ispirano. La sua fenomenologia sperimentale insegna, infatti, ad «accogliere i fenomeni nella loro complessità» (Taddio 2024, 18), naturale e primitiva, senza ridurre questi portati alle prerogative della soggettività costituente, come invece prefiggeva l’idealismo trascendentale di Husserl e di maggiore ispirazione neo-kantiana. Ecco che allora lo spazio, ma soprattutto il tempo, diviene la coordinata principe per cogliere quel farsi struttura di soggetto ed oggetto, dell’apparire in rilievo delle figure che rimangono sullo sfondo percettivo e, finalmente, per abbracciare genuinamente quella dimensione estetica e pienamente sistematica che già da sempre intratteniamo nella relazione con gli altri soggetti e con le cose che ci circondano, e sulle quali non deteniamo mai una presa assoluta, come chiarisce altresì il misterioso concetto di «carne» (Taddio 2024, 87), e di chiasmo, ne Il visibile e l’invisibile. Al contrario, come dimostra il caso della pittura nel pensiero di Merleau-Ponty e che Taddio ha il merito di riprendere e sottolineare con pregnanza in questo testo, le cose e il loro significato si disvelano esattamente nel processo del loro divenire tali, anche considerando, forse paradossalmente, il carattere a tratti contraddittorio di quest’esperienza di nascita costante e imperitura del senso, per come essa prende corpo della prassi percettiva e espressiva, nel caso della produzione artistica che si dipana «in una sola realtà» (Taddio 2024, 15), sebbene secondo gradi di approfondimento differenti.
L’esperienza è proprio il nome di questo curioso concorso, vale a dire di questo mutuale rapporto genetico-costitutivo tra noi e le cose, l’istituzione, come dirà Merleau-Ponty in un corso universitario del 1954, di questa strada non tracciata o pretracciata sulla quale tutti noi camminiamo, un cammino avventuroso che non prevede né fine né un vero e proprio inizio al suo corso, ma solo una «virtualità» (Taddio 2024, 94) che non può cessare di comunicarsi e propagarsi nella storia dell’uomo. All’interno di questo campo, trascendentale, di divenire – e che non disprezza nemmeno accenni deleuziani, nella lettura di Taddio, con e oltre la fenomenologia e la sua «grammatica« (Taddio 2024, 92) – la «stabilità» (Taddio 2024, 36) offerta dalla percezione è sempre provvisoria, l’equilibrio e la sua ricerca sempre differiti nello «spessore» (Taddio 2024, 139) di un presente, come rimarca l’autore in uno dei capitoli più riusciti di quest’opera, a proposito della temporalità. Proprio quest’ultima prevede costitutivi e propositivi sconfinamenti di senso, sia verso il futuro della proiezione che, stranamente, verso la misteriosa e più recondita profondità del passato, e quindi della ritenzione, come del resto insegna la lezione di Proust, e che Merleau-Ponty recupera soprattutto nei corsi universitari dedicati a Il problema della parola (2020), nonché al già citato ciclo su Istituzione e passività (2023).
Ritengo che al lavoro di Taddio vada riconosciuto il merito di aver fatto proprio uno stile eretico, come altresì suggerisce proprio il titolo di un suo saggio, apparso nel 2004 (Taddio 2004), ovvero di aver scelto di lasciare andare alla deriva e quindi sconfinare, appunto, una prospettiva interpretativa e di significato che prima non c’era, o perlomeno che non era ancora presente con questa pregnanza all’interno del contesto offerto dalla già di per sé vasta letteratura secondaria merleau-pontyana in Italia. Per queste ragioni, penso che questo libro possa altresì aprire a proficue interrelazioni e ibridazioni di senso con altre branche della filosofia contemporanea e, perché no, anche della scienza più esatta o dura, come lo stesso Merleau-Ponty avrebbe auspicato a suo tempo, in virtù dell’ampia gamma di riferimenti che la sua opera prende in considerazione.
Bibliografia
- Merleau-Ponty, Maurice. 2020. Le problème de la parole. Cours au Collège de France. Notes, 1953-1954. Genève: MetisPresses.
- Merleau-Ponty, Maurice. 2023. L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955). Prefazione di Claude Lefort. (Edizione italiana a cura di Giovanni Fava e Riccardo Valenti) Milano-Udine: Mimesis.
- Taddio, Luca. 2004. Fenomenologia eretica. Saggio sull’esperienza immediata della cosa. Milano-Udine: Mimesis
- Taddio, Luca. 2024. Maurice Merleau-Ponty. L’apparire del senso, Milano: Feltrinelli.
- Vanzago, Luca. 2012. Merleau-Ponty, Roma: Carocci.
Foto di Art Institute of Chicago su Unsplash
L’a priori e la sua espressione in Mikel Dufrenne
Mikel Dufrenne (1910-1995) è stato un importante fenomenologo francese. In questo articolo mi vorrei concentrare sul concetto di ‘espressione’ nella sua prosa. Per “espressione” intendo il processo comunicativo mediante cui il soggetto conosce, forma e comunica i suoi vissuti o stati d’animo ad altri soggetti in grado di comprenderli. Come cercherò di chiarire, per Dufrenne è necessario che il soggetto si esprima, ovvero che esso si comunichi esteriormente e renda le sue condotte leggibili ad altri, al fine di avere contezza dei suoi stessi sentimenti e del loro valore immediatamente condiviso. È negli altri che il soggetto trova le proprie conferme o smentite; è dal confronto con gli altri che è in grado di riconoscersi ed edificare il senso dell’identità personale. È nell’esteriorità delle sue manifestazioni che il soggetto dimostra di avere un’interiorità, una profondità che trapela in superficie. Continue Reading
Tracce di pre-riflessivo: il soggetto come corpo
Parlare di “stile” in Merleau-Ponty significa rifarsi ad Husserl; per quanto su questo concetto non sia esplicito il riferimento al filosofo tedesco, i due luoghi dell’opera husserliana a cui faremo riferimento non potevano non essere noti al filosofo francese.
Nel §9 della Crisi leggiamo:
Anche se noi possiamo pensare questo mondo fantasticamente mutato e anche se possiamo pensare di rappresentarci il futuro decorso del mondo, in ciò che ci è ignoto, ‘così come potrebbe essere’, nelle sue possibilità: necessariamente noi ce lo rappresentiamo nello stile in cui noi abbiamo il mondo e in cui l’abbiamo avuto finora. Possiamo giungere ad un’espressa coscienza di questo stile nella riflessione e attraverso una libera variazione di questa possibilità. […]. Appunto così ci accorgiamo che, in generale, le cose e gli eventi non si manifestano e non si sviluppano arbitrariamente, che sono bensì legati ‘a priori’ da questo stile, dalla forma invariabile del mondo intuitivo. (Husserl 1972, p. 60)
Nel §61 di Ideen II leggiamo:
In un certo senso, si può parlare dell’individualità come di uno stile complessivo e di un habitus del soggetto che attraversa, nella forma di una concordante unità, tutti i suoi modi di comportamento, tutte le attività e le passività, […]; uno stile unitario nel modo in cui certe cose ‘gli vengono in mente’, nel modo in cui gli si presentano certe analogie, in cui opera la sua fantasia […]. (Husserl 1965, p. 665)
Continue Reading
Fenomenologia della nuova onda
Se il cinema è in grado di portarci nel mezzo, nella transizione, c’è una vera e propria corrente cinematografica che tenta di fare del cinema l’espressione della complessità del reale. Questo movimento, forse il primo ad avere una base intellettuale forte e una struttura culturale coerente e sistematica, è la Nouvelle vague. Nata nella Francia intellettualmente e politicamente engagé degli anni 50 del ‘900 – una Francia esistenzialista, dominata dalla personalità di Jean-Paul Sartre, dai pantaloni a sigaretta, dalle magliette a righe in stile bretone e dal fumo di Gitanes – la Nouvelle vague si vuole svincolare dalla tirannia del visivo, dell’immagine per l’immagine, dal concreto oggettivabile per trasformare il cinema in un mezzo di comunicazione flessibile al pari della scrittura. La macchina da presa usata come una stilografica in grado di lasciare schizzi di inchiostro sul muro delle emozioni umane e vedere quelle emozioni sempre da angolazioni diverse. Il film diventa forma temporale, non una semplice somma di immagini, diventa un tutto che restituisce totalmente il senso della realtà: un tutto che è più della somma matematica delle sue parti. Continue Reading
Il corpo vibrante: la corporeità musicale come modo di abitare il mondo
Questo saggio si propone di analizzare la centralità e le diverse sfumature della corporeità nel pensiero di Maurice Merleau-Ponty in rapporto al ruolo del corpo nella musicoterapia di stampo umanistico. Nucleo dell’analisi sarà il superamento del dualismo mente/corpo che il filosofo opera affermando la centralità della corporeità come mezzo imprescindibile del commercio tra il soggetto e il mondo. Tale riflessione confluirà nella nozione di inter-corporeità che regge l’aspetto relazionale dell’espressione ontologica del corpo vivente e che, attraverso il concetto di carnalità, trova nel linguaggio artistico una modalità privilegiata di espressione. L’obiettivo è di mettere in luce il legame tra tali riflessioni e il sistema di pensiero sottostante alla musicoterapia che, con il lavoro sul corpo vibrante e attraverso il dialogo sonoro, definisce la centralità della corporeità nell’espressione dell’umano. Continue Reading
Una storia di fantasmi
“Teleplastia. Saggio sulla psiche interrotta”, è l’ultimo lavoro di Silvia Vizzardelli, docente di Estetica e Filosofia della musica presso l’Università della Calabria. Si tratta di un testo dall’argomentazione originale e coraggiosa, un contributo atteso a lungo, che prende le mosse a partire da un interessante intervento dell’autrice risalente all’estate del 2019, tenuto a Forlì per la scuola di filosofia “Praxis” (L’atto teleplastico: le sagome del pensiero). Vizzardelli esamina il lemma “tele-”, deputato a definire l’essenza dell’“intervallo”: si tratta infatti della considerazione di quella che l’autrice definisce in questo libro come “actio in distans”, ovvero la facoltà che un atto detiene di avere un’influenza ad un’apprezzabile “distanza” rispetto al soggetto che lo esegue. Ma l’aspetto cruciale di questa visione è che il soggetto mantiene una relazione drammaticamente “senza rapporto” con l’effetto stesso dell’atto causativo, come se questo soggetto stesso giungesse infine a negarne la paternità.

Facendo perno su quella che Einstein battezzò a suo tempo come “spooky action”, vale a dire “atto spettrale”, misterioso (elaborando così un pensiero che consentisse per la sua struttura di concepire la sussistenza di azioni che avessero effetti istantanei ma a ragguardevole distanza, nella dinamica dell’entanglement quantistico), Vizzardelli tenta di sovvertire il paradigma di causalità lineare e transitiva della meccanica e della filosofia classica (ma anche della psicologia e psicanalisi). La meccanica classica, infatti, riconosce lo svolgimento di un esercizio causale unicamente all’azione ed alla passione di due “corpi” contigui, prossimi e adiacenti. A questa logica causale congiuntiva, correlativa e lineare – in breve “humeana”, saremmo portati a concludere – l’autrice contrappone allora l’esistenza di pratiche “magiche”, che sono proprio quelle che si collocano specificamente oltre la “soglia” delle nostre capacità fisiche di soggetti agenti, riconoscendo così la traccia di un effetto del quale siamo, in un qualche modo, responsabili, ma che non è (o non è più) “innervato”, dice propriamente l’autrice, ovvero posto all’interno del novero delle nostre pur ampie possibilità di azione e corrispondente modifica del mondo circostante.
Alla pratica “magica” si riconosce perciò un fondamentale potere di interruzione, di interpolazione causale, di spaccatura o spacchettamento di unioni di organismi comunicanti, e, coerentemente con questo, l’emergenza che consente il rinnovato apprezzamento di un universo di rapporti di correlazione più complessi, un reticolo composto di linee “parallele” di “causalità”, ovvero di “effettività” non meglio definite a causa della stringente povertà del nostro vocabolario, ancora profondamente ancorato ad un lessico di retaggio empirista (in senso classico).
La magia è infatti la dottrina della rinuncia programmatica del possesso gnoseologico, ossia del “sorvolo” del quale aveva parlato Merleau-Ponty nei suoi corsi al Collège de France, rifiuto che si dirige verso una teoria che promulga viceversa il distacco e l’apprezzamento della fluttuazione onirica del senso via via costituentesi: il soggetto che opera magicamente, come uno esperto stregone, è infatti un maestro versato nell’arte occulta, un mediatore che comunica tra i due mondi, unendoli e dividendoli ad un tempo, vale a dire quello visibile del tratto e quello invisibile che lo disegna, come un aruspice che sa scrutare e manipolare le leggi e le catene inferenziali che lo circondano e comandano il suo cosmo, un soggetto che è perciò in grado di “incorporare” nozioni, azioni, stilemi causali, di avere cioè un’influenza mutuale su di loro, ma che non può pertanto “assimilare”, fare proprie queste risorse epistemiche una volta per tutte, vale a dire infine sottrarle al gioco continuo e “forsennato” della distanza, al moto ondoso e rifrangente della “doppia scrittura”, per riprendere un lessico caro a Lévinas o a Derrida e che Vizzardelli ha il merito di fare suo in questo testo.
Ecco che allora causa ed effetto arrivano a somigliarsi, secondo queste raffigurazioni: essi si rispecchiano, si rispondono pur senza intraprendere una diretta interazione, secondo una concordanza che, a ben vedere, non è (più) riconducibile all’azione diretta ed esclusiva di “una” causa, secondo una dinamica proiettiva di significato transeunte. Ciò si esemplifica nel mito di Orfeo ed Euridice riproposto da Rilke e messo in scena dal regista Romeo Castellucci, che Vizzardelli riprende nella sua Introduzione (p. 19). Questa rispondenza si compie quindi nel riconoscimento di due polarità ineliminabili, ovvero nel racconto di una storia che può essere unicamente scritta “a più mani” e da più autori o protagonisti che agiscono (e non patiscono) insieme, secondo una narrazione intricata che svincola finalmente Euridice dall’immaginazione erotica, univoca, di Orfeo cantore: ella infatti, nel poema e nella trasposizione scenica del 2014, “dimentica e dal mondo dimenticata”, non riconosce sorprendentemente la voce dell’amato che la (ri)chiama, ma si riassorbe eclissandosi dolcemente nel torpore monocorde e materico del regno al quale ora e per sempre appartiene, che solo, nell’oscurità, incorpora la sua “scrittura”, dandole traccia.
Nell’arco di quattro capitoli davvero stimolanti (“Uno. Teleplastia”; “Due. Un apparato a due mani”; “Tre. Interruzione e separatezza”; “Quattro. “Non sviluppare, non pontificare”), che seducono e sfidano i limiti del nostro pensare “pontificante”, al quale siamo tradizionalmente e forse colpevolmente più avvezzi, la prospettiva teorica di Silvia Vizzardelli – con quella di altri autori, come Blanchot e su tutti Lacan, quest’ultimo trattato più estesamente nel terzo capitolo – riesce efficacemente a far parlare quella voce del silenzio che cancella eppur unisce il fluire incessante delle nostre parole, che si scoprono, così facendo, scollegate e “magicamente” riunite. Secondo i dettami della “doppia grafia” o scrittura “a distanza” che si imprime su curiose e difformi superfici grafiche tra loro lontanissime, l’autrice riesce infatti a catturare con precisione, appunto “inscrivendoli”, fenomeni “magici” e teleplastici, come l’inconscio psichico che, come brusca ed inspiegabile interruzione dell’attività cosciente, rimodella le restrizioni del modo di intendere il flusso delle nostre azioni e percezioni sensibili. Questo testo merita senz’altro di essere studiato con attenzione, al fine di fare proprio, tra le altre cose, il punto di vista che l’autrice promuove per mettere in pratica una rilettura e ricomprensione di temi classici della storia del pensiero occidentale.
Photo by Bruno Thethe on Unsplash
Sulla passività nel pensiero di Bergson e Merleau-Ponty
L’ontologia si fa estetica. Un nuovo punto di partenza
In Evoluzione creatrice, la passività è raffigurata dalla «materia» (Bergson 1959, 603). Essa è quella «resistenza» che lo slancio vitale deve superare per prolungare la sua «spinta», ma è anche – e soprattutto – la «spazialità» che ne permette la manifestazione, come chiarito anche ne Le due fonti della morale e della religione (Bergson 1959, 1191-1194). Non solo: la materia è anche l’altro volto dell’attività creatrice dello slancio, è la ricaduta o la riconversione attuale di questa forza propulsiva. Essa è il nome del suo «affaticamento», del suo venire meno in quanto «tendenza prima» (Bergson 1959, 595-596; Valenti 2019, 283).
Come ho mostrato in alcuni studi pubblicati, quest’anfibolia non è risolvibile secondo il quadro concettuale offerto da questo testo (Valenti 2020, 268-287; Valenti 2019b). Non è chiaro, in ultimo, cosa esattamente sia questa “corrispondenza” alla virtualità dello slancio bergsoniano, il luogo che accoglie il suo farsi spazio. È il caso, per rispondere a questa domanda, di fare un passo indietro. Occorre prendere in considerazione altri documenti, allo scopo di suggerire una visione più ampia sulla questione della passività. Ecco perché, a mio avviso, è opportuno ripartire da Materia e memoria, uno studio che consente di porre la questione della relazione tra spirito e materia da un punto di vista specificamente estetico.
Tracce di pre-riflessivo: il soggetto come corpo
Parlare di “stile” in Merleau-Ponty significa rifarsi ad Husserl; per quanto su questo concetto non sia esplicito il riferimento al filosofo tedesco, i due luoghi dell’opera husserliana a cui faremo riferimento non potevano non essere noti al filosofo francese.
Nel §9 della Crisi leggiamo:
Anche se noi possiamo pensare questo mondo fantasticamente mutato e anche se possiamo pensare di rappresentarci il futuro decorso del mondo, in ciò che ci è ignoto, ‘così come potrebbe essere’, nelle sue possibilità: necessariamente noi ce lo rappresentiamo nello stile in cui noi abbiamo il mondo e in cui l’abbiamo avuto finora. Possiamo giungere ad un’espressa coscienza di questo stile nella riflessione e attraverso una libera variazione di questa possibilità. […]. Appunto così ci accorgiamo che, in generale, le cose e gli eventi non si manifestano e non si sviluppano arbitrariamente, che sono bensì legati ‘a priori’ da questo stile, dalla forma invariabile del mondo intuitivo.(Husserl 1972:60)
Nel §61 di Ideen II leggiamo:
In un certo senso, si può parlare dell’individualità come di uno stile complessivo e di un habitus del soggetto che attraversa, nella forma di una concordante unità, tutti i suoi modi di comportamento, tutte le attività e le passività, […]; uno stile unitario nel modo in cui certe cose ‘gli vengono in mente’, nel modo in cui gli si presentano certe analogie, in cui opera la sua fantasia […] (Husserl 1965:665)