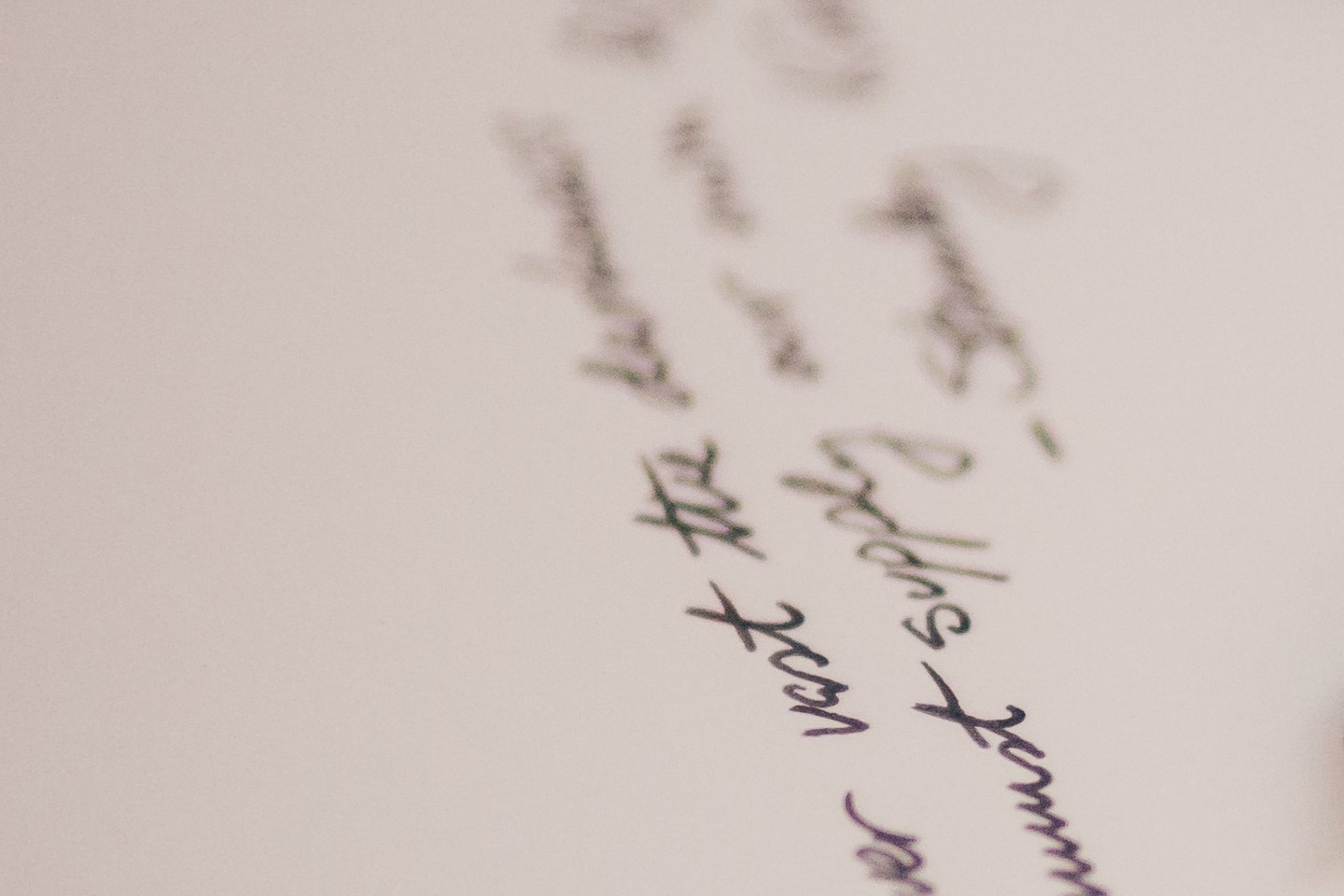Sembra che tra le poche cose che la filosofa María Zambrano portò con sé quando fu costretta all’esilio (a partire dal 1939) c’era anche l’Etica di Spinoza. L’opera del filosofo isolato, come lo definisce la Zambrano, rappresenta dunque una sorta di àncora, un punto fermo intorno al quale edificare una certa identità filosofica, o almeno uno dei riferimenti da tenere sempre a portata di mano. Sono più o meno le stesse cose che un altro grande filosofo del Novecento, morto pochi anni dopo l’esilio della giovanissima Zambrano, Henri Bergson, scrisse a un suo collega. Bergson diceva anche che, pur avversandolo, quando rileggeva l’Etica (e lo faceva con una certa continuità) sapeva di trovarsi nel vero spirito della filosofia.
Come spiega bene l’introduzione di Ludovica Filieri alla pubblicazione del breve saggio della filosofa spagnola La salvezza dell’individuo in Spinoza (Castelvecchi, 2021), il pensatore olandese è per la Zambrano un’isola nel mare del Moderno. Quest’ultimo ha subordinato la vita e la verità alla ragione, dimenticandosi in un certo senso l’uomo. Spinoza, invece, pur muovendo da premesse radicalmente moderne, ha cercato di rispondere alla prepotente domanda esistenziale e non solo a quella gnoseologica.
Ma è interessante – cosa che si evince nel saggio introduttivo di Filieri – capire quando e come Spinoza opera all’interno del pensiero della filosofa. Il saggio appena tradotto (che nel libro si trova anche in versione originale, in lingua spagnola) è scritto in età giovanile, quando la Zambrano sta ancora cercando di strutturare una visione filosofica che la conduca a una ricerca ben definita. Un periodo critico, in realtà, nella formazione della coscienza filosofica della pensatrice che, di lì a poco, inizierà a tematizzare in maniera sempre più determinata il proprio approccio legato a categorie distanti rispetto alla filosofia spinoziana.
La salvezza dell’individuo

Già dal titolo del saggio si può intendere l’inclinazione con la quale la Zambrano affronta il “percorso” all’interno dei cinque libri dell’Etica. Non si parla infatti di una felicità o di una beatitudo dell’individuo, bensì di una sua salvezza. Questo presuppone un punto di partenza che, forse, in Spinoza non è così esplicito o almeno non coincide con quello della filosofa. La Zambrano muove infatti da una convinzione ben evidente: l’uomo è su un crinale attraversato dal rischio di cadere, di perire. La salvezza è dunque un evitare la caduta, è la possibilità di una sorta di strana redenzione. Se in Spinoza si incontra il tema della “salvezza” essa non è mai ricondotta a una visione cristiana, dove tale si dà solo fuoriuscendo dal mondo, tutt’altro.
L’interpretazione che giustamente Filieri definisce «religiosa (quasi cristianizzante)» (p. 31) della Zambrano non è però un limite alla sua lettura. Credo che questa postura renda semmai ancora più evidente quanto Spinoza si differenzi nel contesto della modernità razionalistica occidentale. Nel rapporto con Cartesio – che la Zambrano richiama più volte – il filosofo olandese sembra emergere per distacco, viaggiare in una direzione opposta.
«Ma ecco che Spinoza fa un passo indietro e, molto oltre il dubbio cartesiano, afferma una causa sui, qualcosa la cui essenza implica l’esistenza» (p. 45) scrive la filosofa rintracciando già in questo una prima, pressoché incolmabile, distanza che mette in pericolo l’individuo. L’uomo infatti, secondo la Zambrano, anche in Spinoza vive ed esperisce una “separazione” con Dio e la Natura; separazione che però a livello ontologico non sussiste. «Quindi non c’è nulla di radicalmente estraneo oltre l’uomo. C’è un’identità tra la natura, Dio e gli essere umani. Pertanto, come si spiega la separazione?», si chiede. «Questa separazione sarà una mera incomprensione», risponde la Zambrano dando corpo al “percorso” spinoziano all’interno dell’Etica. (pp. 59-60).
La conoscenza allora è il sentiero che conduce alla “salvezza” dell’individuo. Una conoscenza che per la Zambrano è sì il termine di un percorso che riconduce l’individuo, però, al punto di partenza. La proposizione XXX di Etica V ci riporta al punto iniziale, «agli stessi luoghi del pensiero, della prima definizione che apre l’opera, solo però da un punto di vista diverso» (p. 60).
Dio come physìs e l’uomo solo
In altre parole, l’approdo finale dell’Etica è il suo inizio; Spinoza non fa che offrirci – per la Zambrano – la visione di un pensiero totalizzante e sistemico da tutti i luoghi di osservazione. Se questo, per parte nostra, appare come il grande merito del filosofo olandese, la sua eccentrica modalità di intraprendere un sentiero diverso nella modernità, per la Zambrano è la condizione per cui l’uomo rimane isolato, interdetto, indeterminato.
In Dio – Dio che in quanto Natura la pensatrice spagnola accosta alla physìs greca – l’uomo è solo, quindi. Nonostante l’Etica mostri la potenza della conoscenza (una conoscenza che è “dall’interno” di Dio, si guarda Dio con gli occhi di Dio, avrebbe detto ancora una volta Bergson) la Zambrano rimane convinta che l’uomo non possa che soffrire di non essere Dio. «L’indeterminazione individuale, la solitudine, il naufragio, è la condizione dell’uomo. E davanti a lui si para un mondo di enti, di cose in cui si imbatte e che sono compatibili o contrari rispetto al suo “desiderio di conservazione”» (p. 62).
La scissione tra l’uomo e il mondo, per Spinoza, non sussiste eppure la Zambrano continua a manifestarne il dolore. Per questo può dire che «tutta l’Etica è lo sforzo di ricomprendere l’uomo nel mondo» (p. 63) e che in quanto moto di Dio e non sua creatura preferita, l’uomo «è in lui, separato da lui e prigioniero suo allo stesso tempo» (p. 64).
La pensatrice spagnola, dunque, non si stacca mai dalla sua prospettiva iniziale, da quel vizio tutto occidentale, aristotelico, di considerare l’uomo come sostanza che si contrappone a quella più voluminosa del mondo. Lì, piuttosto che in Spinoza, sta la scissione originaria, il divario e la necessità di escogitare una salvezza. Spinoza rimane al di qua di questa scissione e resta anche il filosofo grazie a cui chiunque può mettere in discussione ciò su cui fonda il proprio pensiero.
Anche María Zambrano nell’esilio umano e spirituale che ha vissuto, in una condizione di separatezza e scissione che ha attraversato prepotentemente anche la sua riflessione, ha visto in Spinoza un diamante di pura luce. Per questo il saggio appena pubblicato ha un importante valore: da un lato ci mostra uno dei tasselli su cui si è formato il pensiero di una delle intellettuali più importanti del Novecento europeo, dall’altro ci conferma come il «filosofo isolato» sia una voce ineludibile per ogni pensiero filosofico.