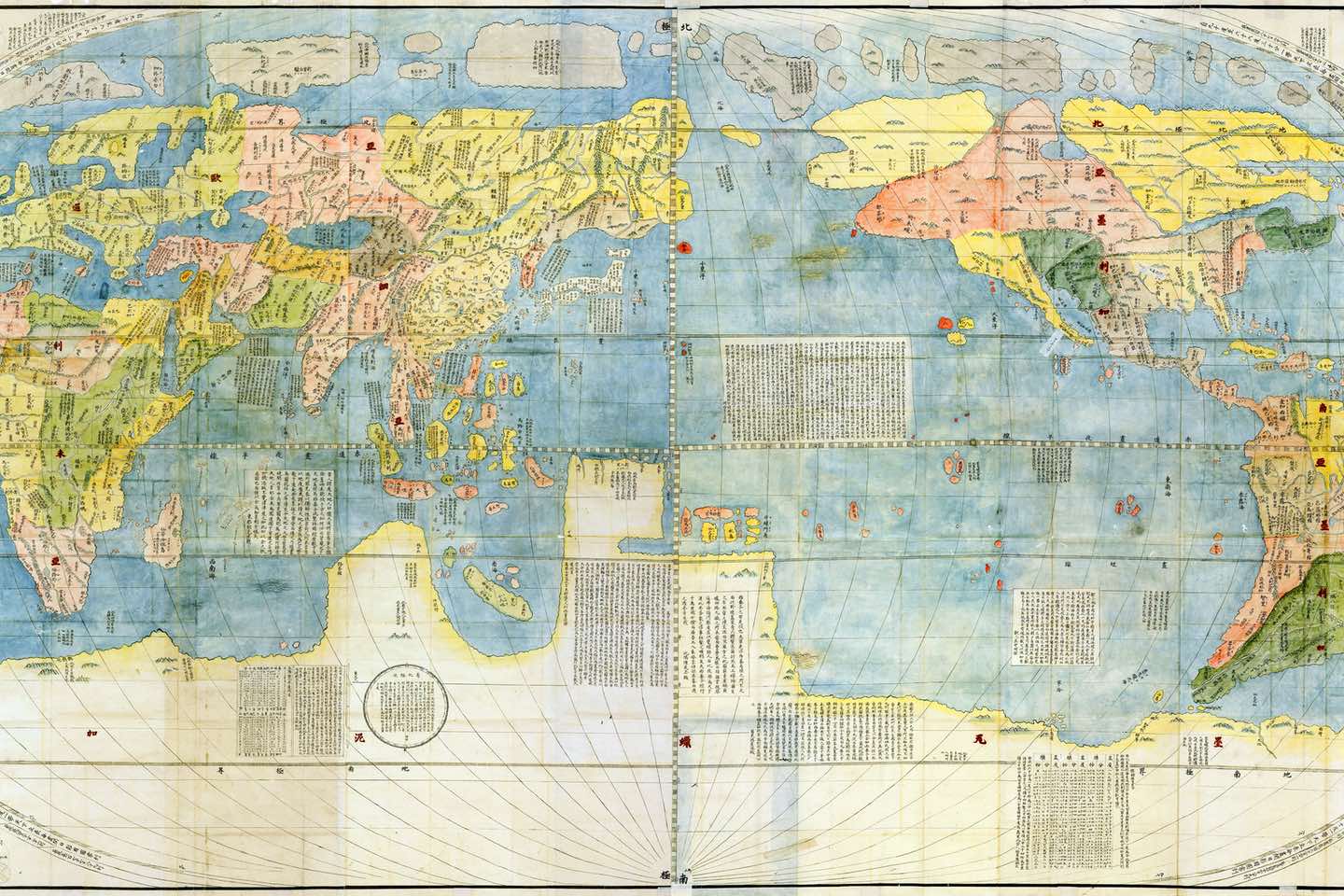Com’è nata la filosofia? Forse non esiste domanda più affascinante per gli amanti di questo straordinario fenomeno che non dobbiamo esitare a definire come una delle espressioni più preziose e decisive della vicenda umana. Perché proprio in Grecia poi? Perché non in seno alle millenarie culture orientali piuttosto, alle quali di certo non mancava la capacità riflessiva? In molti hanno tentato di portare la luce all’interno della nebbia che avvolge la genesi della filosofia, ma pochi hanno avuto la forza argomentativa delle riflessioni di Giorgio Colli. Questo filosofo italiano, poco noto se non per aver curato per Adelphi la traduzione in italiano delle opere di Nietzsche, ha dedicato quasi tutta la sua vita allo studio della civiltà greca delle origini – ne è una prova la straordinaria opera, incompiuta a causa della sua morte prematura, La sapienza dei greci (Adelphi) – producendo riflessioni di grandissimo valore. Quanto segue quindi, non è solo un tentativo di analisi dei suoi studi sui primi passi del sapere filosofico, ma anche quello di dare voce ad una delle personalità più preparate e attente a lasciare che sia la Grecia antica a raccontare se stessa, non viceversa. Continue Reading
Eraclito tra Colli e Heidegger
Quando si affronta il labirinto del pensiero di Eraclito, ci si ritrova sempre a ragionare sul celeberrimo panta rei, sulla coincidentia oppositorum e su di un linguaggio dalle molteplici sfaccettature che rende ancora più complesso avvicinarsi davvero alla radice di un pensiero che è sfuggente per antonomasia. Non a caso Giorgio Colli lo annovera fra quei “filosofi sovrumani” che hanno vissuto sulla propria pelle la tragedia di un sapere tanto profondo da varcare le soglie del pensiero per addentrarsi fin dentro la carne viva del reale. L’intento di questo articolo perciò, sarà quello di provare a mostrare non solo il legame indissolubile che unisce tanto i due nuclei speculativi quanto la forma linguistica tramite cui ci vengono comunicati, ma anche e soprattutto quale sia il sostrato di tale legame. L’impresa è titanica, per questo ci varremo del supporto di due fra le menti filosofiche più brillanti del Novecento: Martin Heidegger e il già citato Giorgio Colli. Perché ricorrere a due letture tanto differenti? Il motivo è molto semplice: perché è straordinario notare come due vie tanto distanti finiscano fatalmente per convergere verso il medesimo argomento di fondo; e ciò ad esclusivo beneficio della ricerca della verità. D’altronde quale altro approccio metodologico avrebbe potuto rendere maggior giustizia al filosofo della multivocità? Continue Reading
Le radici filosofiche del confucianesimo
Prima di proseguire lungo il cammino che ci porterà ad esplorare alcune delle idee e delle suggestioni che – attraversando la Via della Seta – sono giunte fino in Europa, è indispensabile aprire una finestra sui valori che di quel mondo sono stati il fondamento. Addentrarsi fino alle radici del pensiero orientale non è compito semplice, perciò, risulta quanto mai prezioso affidarci ad una guida esperta. Il confucianesimo di Maurizio Scarpari è senz’altro uno dei testi più adatti per iniziarci alla sapienza del mondo cinese. Una civiltà che al di là dai deserti aridi dell’Asia centrale, ha saputo scavare al proprio interno fino a trovare il seme di una morale capace di tradursi in disegno politico, e da lì, ispirare una storia lunga più di quattromila anni. In un percorso che, lungi dall’averla svilita, all’inizio del terzo millennio la trova anzi, più vigorosa e in salute che mai, pronta a giocare quel ruolo da protagonista della scena mondiale al quale da sempre si sente vocata. Perché se è vero che tianxia, il mondo sotto il cielo, ha notevolmente esteso i propri confini rispetto a quello delle prime dinastie, è altrettanto vero che a questa Cina non mancano di certo la forza e la mentalità per ergersi a faro. Come andrà a finire sarà solo il tempo a dircelo, intanto però, cominciamo a capire come tutto ha avuto inizio.
Le radici confucianesimo
C’è un legame molto profondo tra la storia del pensiero cinese e la sua matrice mitologica. Esso affonda senza timore le proprie radici nel regno del mito, in una dimensione velata dalla foschia che avvolge l’inizio stesso della civiltà, e da lì, protende i propri rami, carichi di frutti, oltre le nebbie del tempo, fino ai giorni nostri. Ed è già qui che si mostra chiaramente uno dei valori fondanti, del confucianesimo prima, ma in seguito dell’intera tradizione cinese: una concezione del passato come sorgente di saggezza e sapere.
È proprio dalla fede in questo presupposto che prende forma il pensiero Kongzi (550-479 a.C.), o come abbiamo imparato a conoscerlo noi occidentali, Confucius. Cioè dalla necessità di trovare un appiglio ideologico cui aggrapparsi per fronteggiare e arrestare la degenerazione politica e sociale che ha accompagnato il lento disgregarsi della dinastia Zhou (1046-256 a.C.). Laddove gli uomini contemporanei mostravano segni di debolezza e corruzione, il Maestro trovò nella narrazione – vera o meno che importa – delle gesta dei re-saggi del passato, il seme per fondare una nuova morale capace di guidare l’intera società, verso la virtù.
Il confucianesimo dunque, è un sistema di pensiero che nasce come risposta ai propri tempi, la formulazione dei presupposti di una vita esemplare – che proprio dalla volontà di seguire un esempio ha origine – regolata da solidi principi etici capaci di condurre l’individuo e la comunità intera, verso l’armonia. Di questa vocazione comunitaria, il corpus degli insegnamenti di Confucio non porrà mai in secondo piano l’importanza, anzi, si può dire senza timore che le raccolte stesse delle sue massime sono frutto di un percorso di confronto e condivisione. È impossibile infatti, attribuire con certezza al Maestro la stesura delle formulazioni più antiche dei suoi Dialoghi, il Lunyu, e lo è altrettanto affermare che tutto quanto gli viene attribuito sia suo. Tuttavia, il valore di quanto in essi contenuto non viene minimamente scalfito da tale ombra, perché se non fu l’uomo, fu senz’altro il germe contenuto nelle sue riflessioni a dare origine ad ognuna di quelle parole. Tanto basta. Nel desiderio di tramandare e far evolvere il pensiero del Maestro, i suoi allievi hanno reso un servizio prezioso non solo a lui, ma a tutta l’umanità.
Altrettanto fondamentale nel pensiero confuciano, è la centralità della dimensione umana a discapito della speculazione. Questa matrice pratica, che verrà poi sfruttata dal mondo cristiano, e da Matteo Ricci in particolare, per instillare gocce di fede in una cultura votata all’agire etico, sarà uno degli elementi cardine del proprio successo. Nella Cina degli albori come in quella odierna. Perché è proprio nel suo desiderio di promuovere l’ordine sociale necessario a contrastare le incertezze della politica di allora, che ancora oggi, il confucianesimo, si pone come una forma eccezionale di educazione civica. Ed è in tale veste che ora come allora, ci incalza con la sua capacità di proporre linee di condotta tanto semplici quanto condivisibili e sempre attuali. Qui sta senz’altro il più grande successo del pensiero di Confucio, nell’aver saputo trovare nel passato più remoto i germogli da piantare nel presente affinché un nuovo futuro, un futuro migliore, fiorisca.
La via del dao e la ricerca dell’equilibrio
Che fra le intenzioni di Confucio non ci fosse quella di fondare una nuova religione o di dare vita ad un pensiero mistico, appare chiaramente dalle sue parole: «Dedicarsi a ciò che è giusto per il popolo e mostrare rispetto per spiriti e divinità pur tenendoli a debita distanza, è indice di sapienza». Rimarrà perciò deluso chiunque, in questo pensiero, cerchi una dimensione spirituale analoga a quella che si può invece trovare nel daoismo. Una corrente di pensiero che nasce negli stessi anni del confucianesimo e intorno ad un concetto che anche in questo svolge un ruolo fondamentale, il dao, ma che ben presto, si discostò dalla dimensione umana, in cerca di qualcosa di più.
Che cos’è il dao? Innanzitutto, per poterci avvicinare ad un concetto tanto fluido, è fondamentale chiarire che esso, perlomeno nel confucianesimo, non ha nulla a che fare con la divinità. Essa piuttosto, è riconducibile a Tian, il Cielo. Lungi dall’assegnare sembianze umane dunque, la tradizione cinese ripone nell’elemento naturale che più di tutti sovrasta e veglia sul mondo, il ruolo di simbolo del divino. È proprio da questa entità distante, più simile a un supervisore che a un protagonista delle vicende del mondo, che Confucio impara il valore del silenzio. Già gli antichi saggi «trattenevano le parole per timore di non riuscire a dar loro seguito nella pratica», tuttavia qui si tratta di un piano diverso. Non è il silenzio del timore, ma quello della consapevolezza che Confucio scopre nel Cielo. Non c’è bisogno ch’egli parli o si spieghi, la sua opera è sempre presente e visibile «Non se ne vede il lavoro, ma se ne vede l’effetto», questa è la saggezza che ci insegna il Cielo, agire senza agire, perché c’è già sempre un agire al di là del nostro non agire. Essere modelli con il nostro comportamento e lasciare che sia questo a parlare per noi e a irradiarsi come forza morale per le persone intorno a noi. Così nasce un maestro, imparando il silenzio di Tian. E il dao è la grande strada da percorrere per diventare capaci di una simile saggezza.
Wen è il primo passo, la cultura, elevarsi attraverso lo studio e l’educazione pone l’individuo in sintonia con il dao e lo aiuta a migliorare la propria posizione sociale – effetto inscindibile dal cammino lungo la via che conduce alla virtù – e a contribuire alla crescita armoniosa della società. «È l’uomo che può rendere grande il dao, non il dao che può rendere grande l’uomo», e lo studio continuo dei grandi insegnamenti del passato è l’elemento fondamentale per avere la conoscenza necessaria a destreggiarsi nei diversi contesti che la vita ci sottopone. Ecco dunque un altro carattere fondamentale della via confuciana, essa non è un immutabile statico al pari dei 10 comandamenti, essa non va scolpita su pietra e tramandata identica a se stessa per tutti i secoli dei secoli. Tutt’altro. «Solo chi comprende a fondo il nuovo sulla base di un’attenta analisi di quanto è già noto è degno di diventare maestro», perché la mutevolezza dei momenti fa sì che neppure il riprodurre fedelmente ogni scelta già presa dagli antichi saggi possa, di per sé, essere garanzia di un agire virtuoso. Occorre saper scegliere, saper pesare con estrema attenzione le proprie scelte, avendo la capacità di riflettere prima, sulle conseguenze che queste comporteranno per noi e per gli altri. È questa la facoltà che contraddistingue il sovrano illuminato come il saggio, è ming, «la capacità di comprendere ogni situazione valutandola simultaneamente e con lucidità da tutte le angolazioni possibili, liberi da ogni pregiudizio o vincolo». Solo attraverso lo studio si può sperare di limare la materia grezza che dà forma all’uomo, e ne offusca il giudizio, per condurlo al giusto equilibrio.Per far sì che raggiunga la condotta virtuosa e si erga a modello capace di influenzare gli altri.
Ad aiutarci in questo difficile compito ci sono i li, l’insieme di norme comportamentali e riti che la tradizione ci ha riportato quali binari per dare un assetto stabile alla propria persona. È dunque dal mantenere in equilibrio gli insegnamenti, i li e yi (la capacità di un giudizio morale) che discende la possibilità di vivere in sintonia con il dao, con il cammino che conduce alla virtù. Come preciserà Xunzi, uno degli allievi più importanti di Confucio «Il dao degli antichi sovrani consiste nell’esaltare l’amore per il prossimo e nel metterlo in pratica seguendo la dottrina del giusto mezzo (zhong). Che cosa s’intende con giusto mezzo? Avere un comportamento appropriato nel rispetto dei riti e delle norme di comportamento (liyi). Il dao non è il dao del Cielo e nemmeno il dao della Terra: è il modo in cui l’uomo si comporta (dao), il modello che la persona esemplare segue (dao)».
Il junzi e la società giusta
La decisione del proprio comportamento è dunque un momento fondamentale del vivere sociale che, per essere misurabile, deve poggiare su parametri oggettivi di decisione e su una capacità di giudizio legata alle norme. Junzi è il nome che viene dato a colui che sa costruire in modo armonioso la propria personalità e sa comportarsi in modo adeguato grazie al rispetto dei li e di yi, anteponendo l’amore per il prossimo all’interesse personale come in una famiglia. Ed è all’interno della famiglia che tutto inizia, è alla sua basilarità che il confucianesimo si ispira come alla matrice naturale sulla quale si basa ogni rapporto umano. Qui, l’amore e il rispetto dei vincoli familiari – in particolare la sottomissione del figlio al padre – sono il fondamento dell’equilibrio, ed è a questi stessi principi che la società deve rifarsi, se vuole mettere in atto un equilibrio altrettanto solido e fecondo. Così come è fondamentale, per l’individuo virtuoso, saper irradiare in direzione del prossimo, i medesimi valori che coltiva all’interno della propria famiglia. Di tutti, il più importante è senz’altro il ren, l’amore verso il prossimo, è questo ideale dinamico che deve accompagnare ogni tappa del percorso di crescita dell’individuo affinché possa, con il suo operato, far crescere l’intera società. Ed è proprio da questa centralità del rapporto con gli altri che nasce la seconda virtù confuciana per eccellenza: shu, «non imporre agli altri ciò che non desidereresti per te stesso». È grazie a shu che Confucio riesce a delineare il metodo del ren, ossia lo spingerci nei panni del prossimo per migliorare la capacità di comprendere e valutare le nostre azioni in funzione della relazione con gli altri. A queste due si affiancano zhong, la virtù che prescrive di fare sempre il proprio dovere, xin, la sincerità, e yi, che come abbiamo già detto è la capacità di giudicare in modo appropriato. Seguire questi modelli significa pòrci sulla via per diventare simili ai saggi dell’antichità e raggiunge la dimensione dello shengren (il saggio). Tuttavia, essa pare più come un ideale di riferimento che non come una dimensione realmente alla portata dell’uomo, che, piuttosto, secondo Confucio, deve ambire alla dimensione dello junzi, della persona esemplare per virtù e nobiltà d’animo.
Il ritorno di un vecchio saggio
Il modello di società proposto da Confucio dunque, coglie nel mantenimento dell’equilibrio l’elemento fondamentale di ogni benessere. Esso infatti, comprende chiaramente che non ha senso tentare di far prevalere, una volta per tutte, un valore sul suo opposto, yin su yang, o viceversa, ma che è importante far sì che essi si trovino inarmonia e nessuno dei due tenti di prevalere sull’altro. Ben vengano dunque anche l’esercizio della violenza e delle armi, se necessari a correggere chi disattende alle direttive del sovrano, perché infondo, si configurano come mezzo per il mantenimento dell’ordine. Il quale però, va promosso anche attraverso altre vie. Tanto più che le contingenze della vita, rendendo impossibile a molti l’accesso allo studio e quindi all’elevazione, rischiano di trasformare il popolo in una pedina al servizio di fomentatori e rivoltosi, che nella rottura dell’equilibrio vedono la propria via d’accesso al potere. È per questo che è parimenti importante per il sovrano mostrarsi retto, oltre che autorevole,perché «se si governa con le leggi e si mantiene l’ordine con le punizioni, il popolo cercherà di evitare le punizioni e non proverà vergogna per le proprie mancanze. Se invece si governa con magnanima virtù e si mantiene l’ordine con i li, il popolo proverà vergogna per le proprie mancanze e si correggerà». Ancora una volta dunque, è nell’innalzarsi che sta il segreto per far sì che anche gli altri si innalzino con noi e si possa, tutti insieme, dar vita ad una società retta.
Innalzando una condotta basata su rispetto e amore per il prossimo, il confucianesimo ha favorito l’emersione di una civiltà capace non solo di far prevalere l’istinto comunitario sull’individualismo, ma anche di fare proprio di tale caratteristica il suo maggior punto di forza. Per questo non è un caso che la Cina contemporanea abbia saputo cogliere in Confucio quel il saggio maestro del passato capace di ispirare il futuro, che egli stesso, a suo tempo, aveva cercato nei saggi-re dell’antichità. Già una volta questa scelta ha permesso alle genti dello Zhongguo (Stati del Centro, come la Cina chiamava se stessa anticamente) non solo di unificarsi all’insegna di una stessa identità culturale, ma anche si riunire e dominare su tutto il tianxia; perché non dovrebbe poter funzionare di nuovo?
La vita come pericolo e salvezza contro il danno della storia
L’interpretazione del percorso storico ha da sempre costituito uno degli elementi di maggiore interesse per il pensiero occidentale, soprattutto per quello filosofico. Se da un lato il passato va studiato e compreso, dall’altro, affinché tale attività raggiunga il proprio scopo – cioè favorire la sopravvivenza – occorre poter determinare il futuro conseguentemente. Una delle interpretazioni che hanno avuto sicuramente più successo è lo storicismo di matrice hegeliana, ossia il riconoscimento di un telos all’interno del percorso storico per cui esso sarebbe il farsi atto dello Spirito Assoluto. In altre parole, tutto ciò che accade è espressione di ciò che deve essere, per il semplice fatto che è così e non altrimenti che l’ha voluto lo Spirito nel suo farsi Mondo. Un atteggiamento che spinge nel passato le radici del futuro e subordina l’universalità della ragione e il suo potere, al giudizio della storia. Questo totale depotenziamento della dimensione umana ha incontrato diverse critiche, ma nessuna dirompente come quella messa in tavola dal giovane Nietzsche nella sua II inattuale Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Punto di partenza di una riflessione che lo accompagnerà per tutta la sua vita e che porterà il suo slancio verso un futuro diverso, faccia a faccia con le radici più antiche del pensiero. Continue Reading
Europa e Cina sotto le lenti dei filosofi di ieri e di oggi
Odi et amo. È forse questa l’espressione che meglio di tutte riesce a cogliere la natura del rapporto tra Occidente e Oriente, per lo meno per come lo si percepisce da Occidente. Tutto, e il suo contrario, contemporaneamente. Come nella dottrina dei contrari di Eraclito, questi due momenti del mondo vivono una perenne contrapposizione – ieri più geografica e culturale, oggi economica e politica – all’interno della quale però, in sporadici punti di contatto, hanno saputo scoprirsi molto più simili di quanto non potesse sembrare.
Fra le tante voci che hanno contribuito ad approfondire questo guardarsi da lontano – spesso troppo lontano – una delle più autorevoli è senz’altro quella di Eugenio Garin, celebre storico della filosofia che nel 1975, con il suo saggio Alla scoperta del “diverso”: i selvaggi americani e i saggi cinesi, contenuto nella raccolta Rinascite e rivoluzioni, s’interrogava sul ruolo giocato dalla Cina nell’evoluzione della civiltà europea nell’età moderna.
Dopo di lui, un altro studioso che più si è prodigato affinché tali punti di convergenza potessero emergere e rendersi visibili a beneficio di entrambe le parti è Filippo Mignini. Docente universitario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, Mignini è stato anche direttore dell’Istituto Matteo Ricci per le relazioni con l’Oriente. Nel suo Europa e Cina, uscito in questo turbolento 2020, Mignini tenta di ricostruire le tappe fondamentali del percorso di assimilazione del pensiero orientale dall’Europa illuminista, per farne il punto di partenza di una speculazione che allunga il suo sguardo fino al futuro prossimo.
Due voci che partendo da punti diversi, cercano di accorciare le distanze, per lo meno dal punto di vista mentale, fra due mondi che proprio nel dialogo basato sulle reciproche differenze potrebbero trovare la chiave per un nuovo mondo. Continue Reading
Affrontare l’enigma
In questa terza e ultima parte della nostra analisi di Filosofia dell’espressione, si schiude la crisalide. Il percorso attraverso il quale ci ha condotto Colli però, ci sorprende fino alla fine. Egli infatti non ci porta, come sarebbe stato legittimo aspettarsi, finalmente fuori dal labirinto che ha appena finito di mostrarci bensì, ci riporta al suo inizio, incalzandoci con un quesito che ricorda storie dal grande peso: hai il coraggio di rientrare?
Continue Reading
Giorgio Colli e lo scacco al Logos
Nel riflusso, titolo della seconda parte di Filosofia dell’espressione, Colli ci porta all’interno del labirinto costruito dal logos nel tentativo di celare il più oscuro dei suoi segreti. Come un filo di Arianna, il testo ci guida attraverso un’intricata rete di categorie che viste insieme articolano una logica tanto complessa quanto radicata in profondità. L’esito di tale percorso è ancora incerto, ma proprio alla fine sembra di scorgere un piccolo spiraglio di luce. Seguirlo è l’unica possibilità rimasta.
Lo sforzo linguistico di Colli per nominare ciò che si nasconde
C’è tutto lo spessore dei grandi testi filosofici fra le pagine di Filosofia dell’espressione di Giorgio Colli. Questioni fra le più cogenti della tradizione filosofica, come le condizioni di possibilità del conoscere, il ruolo del linguaggio, l’attingibilità della verità dell’essere, vengono affrontate con un approccio estremamente rigoroso per la logica che lo muove. Perché è forse in quest’ultimo passaggio che si comprende la partita sul pensiero di Colli. La sua passione, possiamo dire persino la sua affinità con l’articolarsi del pensiero greco lo portano a dare vita ad un linguaggio che è perfettamente in linea con i contenuti che propone. Così, al velamento che ci separa dall’essenza del mondo, fa da specchio una scrittura che pur nello svelare non cede mai alla tentazione della dimostrazione perché troppo più grande è la potenza rivelatrice dell’intuizione per lasciare che sia la ragione a farsi portatrice della verità. Ed è proprio in questo gioco fra svelamento e nascondimento che il filosofo italiano conferisce un taglio unico alla propria riflessione, di difficile lettura ma anche di grande forza nel momento in cui riesce a far breccia fra le trame del pensare tradizionale.
Continue Reading
Quando il pensiero si fa scrittura filosofica
Lo studio dei grandi testi filosofici è l’ispirazione originaria di RF perché crediamo che solo in un loro attento ascolto sia possibile il ritorno a quell’universitas filosofica ormai scomparsa dietro le ragioni sia pur legittime della struttura e del ruolo. Si tratta di una questione tanto di contenuti quanto di metodo. Per i contenuti, in quanto solo con lo studio diretto dei grandi testi è possibile sperare di avere grandi pensieri: filologia e filosofia sono sorelle strette. Per il metodo, in quanto non si tratta soltanto di leggere ma di dialogare co’ l’antiqui spiriti (intesi evidentemente non solo in termini cronologici ma soprattutto spirituali) per comprendere anche le condizioni grazie alle quali un pensiero riesce a farsi scrittura mantenendo la sua ricchezza e fecondità. La serie, ogni quarta domenica del mese, sarà aperta proprio con questo tema attraverso uno studio su Filosofia dell’espressione di Giorgio Colli, testo di grande complessità consistente in un coraggioso tentativo di scavare fino al punto in cui il pensiero si unisce alla vita, istante immane in cui l’intuizione si fa scrittura.
Nietzsche, lo Stato contro l’individuo
Quando si parla di politica, all’interno del pensiero di Friedrich Nietzsche, molto spesso si finisce per ragionare più su cosa abbiano implicato le sue considerazioni — si faccia qui lo sforzo “sovrumano” di metterne fra parentesi il contenuto, già abbondantemente discusso in altre sedi — che non sui meccanismi di pensiero e di analisi della realtà che ne hanno favorito l’emersione e l’articolazione. Dal complicatissimo rapporto con i connazionali del suo tempo a una certa ipersemplificazione nella lettura della teoria evoluzionistica darwiniana, sono moltissime le fonti d’approvvigionamento per l’elaborazione della sua riflessione. La maggior parte delle quali spesso nascosta dietro criptocitazioni e riferimenti allusivi. Ragione per cui, se vogliamo provare ad avvicinarci alle reali implicazioni di una figura tanto controversa e allo stesso tempo tanto influente per la nostra società, dobbiamo fermarci ad analizzare alcuni passaggi chiave.
Uno degli elementi di maggiore interesse quando si parla di approccio politico nietzscheano è costituito dall’analisi del ruolo dello Stato nella vita degli individui. Scossa dai moti rivoluzionari, dallo sviluppo delle prime formule democratiche e dall’avvento del socialismo questa istituzione, che un tempo assorbiva e catalizzava le forze migliori di una società (si veda in proposito l’aforisma 179 di Aurora) ha finito per ergersi ai suoi occhi a baluardo della nientificazione. Concetto espresso con estrema chiarezza nel passaggio del Così parlò Zarathustra intitolato Del nuovo Idolo dove, pur ammettendo il ruolo necessario dello Stato, come necessari sono i mali della vita, Nietzsche lo definisce “la morte dell’individuo”. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare però, una simile considerazione non emerge, o per lo meno non solo, in relazione al suo carattere restrittivo nei confronti delle libertà individuali che esso esige attraverso l’apparato normativo, bensì dalla sua esaltazione delle mediocrità come virtù. A partire da qui, gli “statolatri” che dominavano la scena culturale ottocentesca in Germania, sono la massima espressione di tale annullamento, perché nell’adorare questo idolo appunto, danno forma a quanto il giovane Nietzsche aveva già intuito nell’aforisma 126 del primo volume di Umano troppo umano: la stabilità rafforza l’efficienza delle comunità in cui ognuno fa la sua parte, ma le istupidisce. Non l’equilibrio, ma l’opposizione e lo scontro portano all’accrescimento. Per questo poi in Al di là del bene e del male arriverà a dire che il piano politico è il terreno di pascolo per il popolo-gregge di armenti, perché nell’affermarsi dei movimenti democratici si celebra la massima espressione della volontà di farsi niente. Nello Stato democratico infatti, è il popolo stesso a porre sulle proprie spalle il giogo del “Tu devi” di zarathustriana memoria. Ed è proprio in questo passaggio che si cela l’estremo inganno del “governo del popolo”. L’istinto all’obbedienza si è radicato tanto a fondo nell’uomo che, nel momento dell’esercizio del potere politico, esso finisce per generare una “cattiva coscienza” in chi è chiamato ad esercitarlo.
Il predominio etico dell’obbedienza, infatti, è penetrato tanto a fondo nel sentire collettivo da rendere necessario a chi detiene il potere senza averne lo spessore adatto l’atteggiarsi a esecutore di ordini più antichi o superiori; siano essi degli antenati, delle leggi o di Dio. La disabitudine alla potenza genera un rifiuto delle possibilità che essa potrebbe aprirci, che si manifesta attraverso la forma del mantenimento dell’equilibrio, del traghettare ciò che abbiamo ricevuto così come l’abbiamo ricevuto. Tuttavia, come insegnano anche le Sacre Scritture attraverso la parabola dei talenti, non c’è investimento peggiore della viltà e della mediocrità per sprecare se stessi. Per questo Nietzsche preferisce un Napoleone che comanda con coraggio e orgoglio, a quell’ “addizionamento di uomini assennati dell’armento” che dietro il nome di democrazia cela solo l’ennesimo tentativo di rimpiazzare il montone-capo del popolo, senza avere la grandezza per farlo. Come precisa in Genealogia della morale (Adelphi, p.74) infatti: questa “cattiva coscienza” è una malattia autoinflitta che esprime la “sofferenza che l’uomo ha dell’uomo, di sé”, estrema conseguenza dell’ormai istituzionalizzata impossibilità di rivolgere all’esterno i propri istinti prevaricatori. Ancora una volta Nietzsche affonda le radici del proprio pensiero in quell’origine animale dell’umano che trova una perfetta formulazione nella “fedeltà alla terra” additata da Zarathustra agli uomini che affollavano la piazza del mercato nel celebre Prologo di Zarathustra. Una repressione dunque che costringe l’individuo a trasformare quegli stessi istinti che l’avevano un tempo innalzato, ad armi scagliate verso se stesso, nel disperato tentativo di disinnescarne la portata oppositiva, interiorizzandoli, imprigionandoli nel proprio io. Ecco dunque che attraverso uno straordinario percorso manipolatorio, lo Stato chiude il cerchio del proprio processo di annichilimento dell’individuo, arrivando perfino a farlo sentire colpevole di poter esercitare quel potere tanto desiderato di poter cambiare le cose, o in qualche modo di autodeterminarsi.
Nel definire questa natura dello Stato come uno dei principali nemici del proprio pensiero, Nietzsche non rivela solo la propria simpatia per posizioni prossime all’anarchia, ma soprattutto il suo approccio estetico all’animalità insita nell’uomo. Animalità che però, come ribadisce nello stesso passaggio di Genealogia della morale, pur trovando una limitazione nella tirannide che lo Stato esercita su di essa, ne costituisce allo stesso tempo l’atto di nascita. Infatti, è proprio attraverso l’affermazione di quegli “artisti” che per primi hanno innalzato gli istinti di dominio e di prevaricazione (lontano da qualsiasi traccia di cattiva coscienza) che si è giunti all’istituzionalizzazione del potere. Quando la sete di dominio che portava a ridurre la libertà degli altri in nome della propria affermazione, è penetrata nell’habitus di una cultura al punto da far sì che l’obbedienza stessa diventasse espressione della volontà (la devozione nei confronti del nuovo signore della guerra che era riuscito ad imporsi era garanzia di sopravvivenza), ecco che nasce la cattiva coscienza, e con essa la necessità del superuomo a rompere tali catene. D’altronde, come ricorda Nietzsche nella conclusione del passaggio già citato di Genealogia della morale, è proprio tutto questo rivoltarsi contro se stessi a costituire la migliore speranza che “il grande fanciullo” che gioca ai dadi di eraclitea memoria, possa condurci verso un tale superamento.
Sullo sfondo di tutto questo impianto argomentativo però, non bisogna dimenticare quanto ci dice Zarathustra nel brano Di grandi eventi, dove, per scagliarsi contro l’illusoria fiducia del rivoluzionario nei confronti dei grandi cambiamenti, Nietzsche ci ricorda che per il filosofo ciò che conta non cambia insieme ai governi. Proprio da qui parte Sossio Giametta per criticare il filosofo tedesco e il suo sminuire l’importanza della politica. Al di là di tutto infatti, nel suo seno si determinano ingiustizie e soprusi che non possono dirsi “non importanti”. Parimenti, non c’è rinnovamento senza punto di rottura, tanto sul piano politico quanto su quello individuale. Inoltre, se è vero, come sostengono Aristotele e Spinoza, che l’uomo è animale politico, allora, spendersi per promuovere l’accrescimento dell’individuo, in qualunque senso ciò si voglia intendere, equivale in fondo a portare avanti una battaglia che poi non può non ripercuotersi sul piano politico. Magari indirettamente, ma ciononostante inevitabilmente. Perciò, anche se il superuomo è un progetto tutt’altro che politico, suo malgrado esso finisce per rovesciarsi su quel piano. In passato, seppure in buona parte frainteso e comunque come frutto spurio della statolatria di matrice hegeliana, lo ha fatto delineandosi in forme totalitarie e d’intolleranza su base razziale, in futuro, magari, saprà dirottare quell’indisposizione alla tolleranza, verso la furfanteria e l’indolenza e accompagnarci definitivamente verso un oltrepassamento della politica; per lo meno di come fino ad oggi l’abbiamo conosciuta.