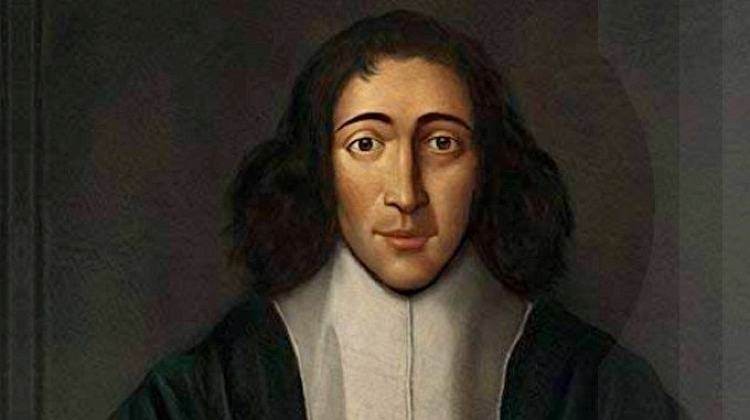Borges, nei celebri versi dedicati a Spinoza, lo esprime in modo efficace ed evocativo: «Qualcuno costruisce Dio nella penombra». Non è stato il solo, fortunatamente. Chi, rifiutando l’idea del cristallo o della cattedrale di ghiaccio, cioè come un complesso chiuso e definitivo, ha considerato la filosofia di Spinoza come un sistema nel suo formarsi, è stato un giovane studioso italiano, Fausto Meli, vissuto negli anni tra le due guerre mondiali e scomparso in modo prematuro a soli 22 anni. Di lui abbiamo poche notizie se non che fosse siciliano, insegnante di Filosofia all’Istituto Magistrale di Trapani, e che avesse studiato per un periodo alla scuola Normale di Pisa. I suoi scritti sono tre: uno sul pensiero politico e religioso di Fausto Socino; un altro su Jacopo Aconcio; un terzo sulla metafisica razionalistica di Spinoza. Tutti e tre i saggi sono raccolti nel volume intitolato Spinoza e due antecedenti italiani dello spinozismo, editi da Sansoni nel 1934 con prefazione di Giuseppe Saitta. Nell’ultimo saggio, troviamo una tesi originale quanto ben argomentata: quella secondo cui la filosofia di Spinoza non è scienza delle cose eterne, ma di ciò che ha interesse e valore, che distingue «tra una scienza che si giova di proposizioni che descrivono l’oggetto come esso è fuori dell’intelletto, ed una che si giova di definizioni che spiegano l’oggetto come è concepito o può essere concepito da noi» (p.100). Continue Reading