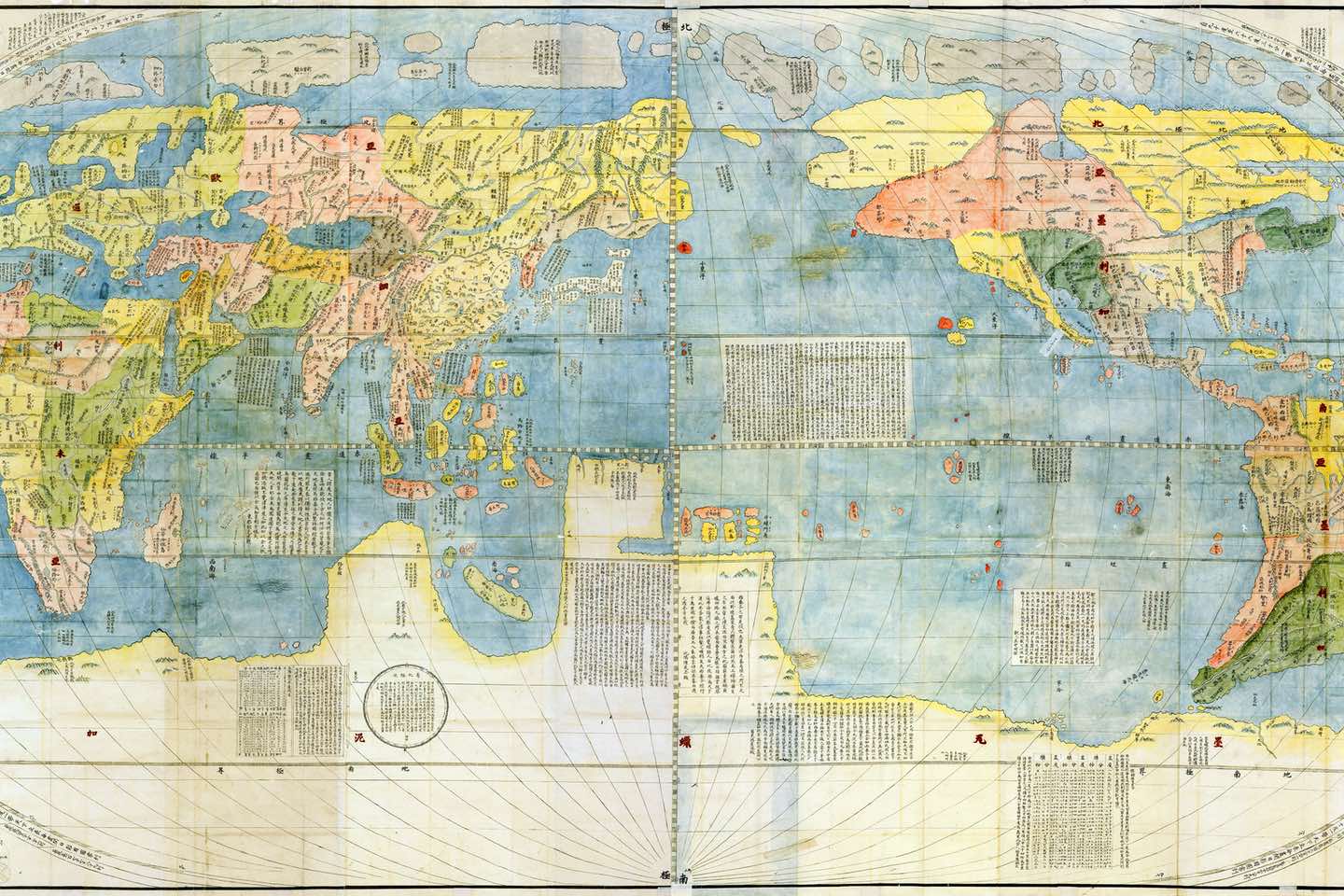Odi et amo. È forse questa l’espressione che meglio di tutte riesce a cogliere la natura del rapporto tra Occidente e Oriente, per lo meno per come lo si percepisce da Occidente. Tutto, e il suo contrario, contemporaneamente. Come nella dottrina dei contrari di Eraclito, questi due momenti del mondo vivono una perenne contrapposizione – ieri più geografica e culturale, oggi economica e politica – all’interno della quale però, in sporadici punti di contatto, hanno saputo scoprirsi molto più simili di quanto non potesse sembrare.
Fra le tante voci che hanno contribuito ad approfondire questo guardarsi da lontano – spesso troppo lontano – una delle più autorevoli è senz’altro quella di Eugenio Garin, celebre storico della filosofia che nel 1975, con il suo saggio Alla scoperta del “diverso”: i selvaggi americani e i saggi cinesi, contenuto nella raccolta Rinascite e rivoluzioni, s’interrogava sul ruolo giocato dalla Cina nell’evoluzione della civiltà europea nell’età moderna.
Dopo di lui, un altro studioso che più si è prodigato affinché tali punti di convergenza potessero emergere e rendersi visibili a beneficio di entrambe le parti è Filippo Mignini. Docente universitario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, Mignini è stato anche direttore dell’Istituto Matteo Ricci per le relazioni con l’Oriente. Nel suo Europa e Cina, uscito durante il turbolento 2020, Mignini tenta di ricostruire le tappe fondamentali del percorso di assimilazione del pensiero orientale dall’Europa illuminista, per farne il punto di partenza di una speculazione che allunga il suo sguardo fino al futuro prossimo.
Due voci che partendo da punti diversi, cercano di accorciare le distanze, per lo meno dal punto di vista mentale, fra due mondi che proprio nel dialogo basato sulle reciproche differenze potrebbero trovare la chiave per un nuovo mondo. Continue Reading